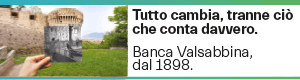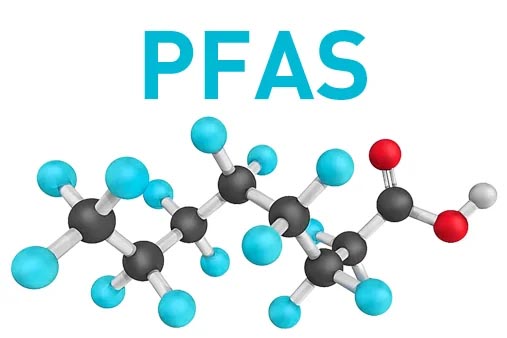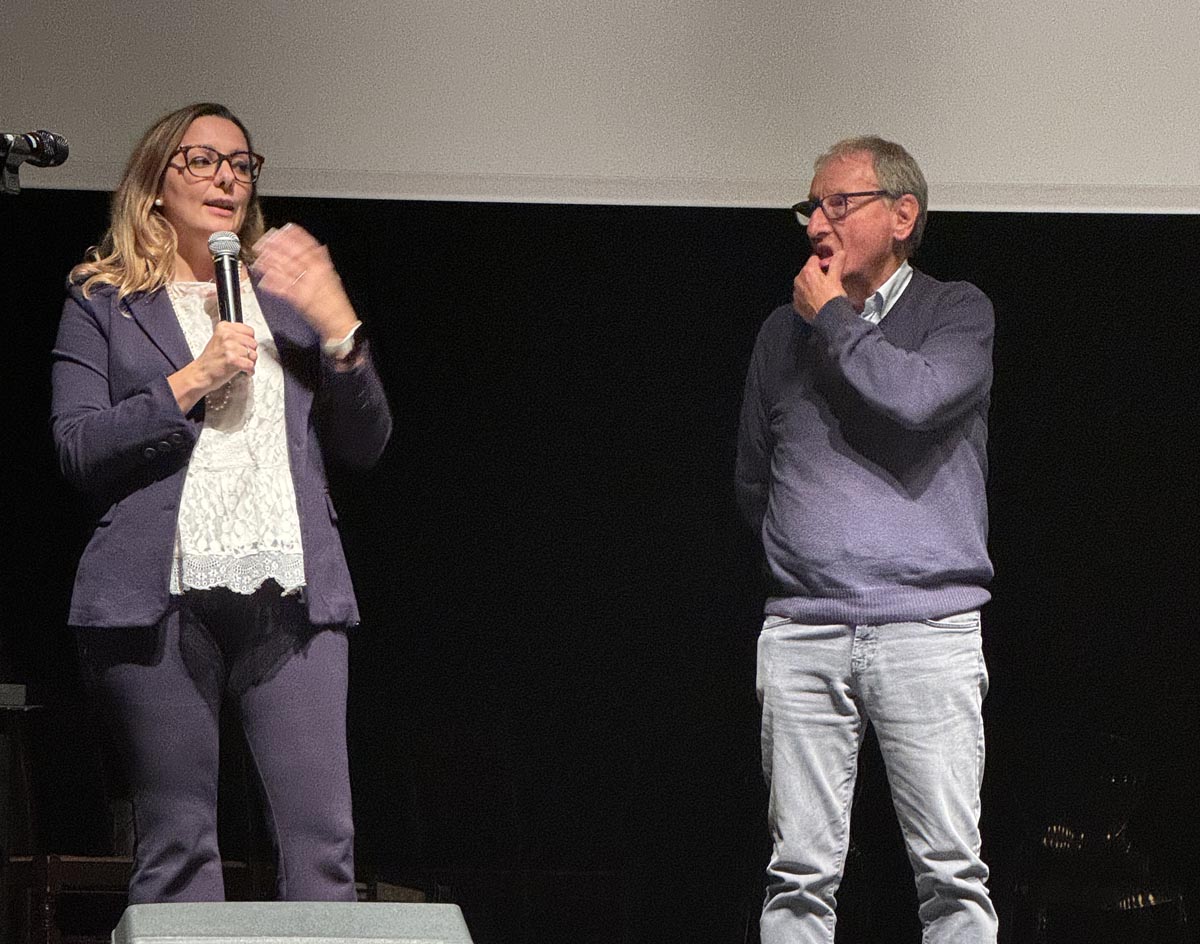Quando parliamo di salute, di che stiamo parlando?
Di cosa parliamo quando parliamo di salute? L'evoluzione del concetto dall'antichità fino ai tempi più recenti
“Quando parliamo di salute, di che stiamo parlando?” Per il senso comune la risposta è ovvia: “stare bene.” Non a caso la domanda che più spesso si pone per saperlo è proprio: “Come stai?” che è anche uno dei modi più usati per aprire una comunicazione, una formula di cortesia che spesso non prevede di prestare attenzione alla risposta. Tant’è che c’è chi non accetta da qualsivoglia di rispondere a tale domanda. Domanda retorica, che non richiede una risposta sincera, per questo mal considerata dagli amanti della verità. Eppure, a tutti voi sarà capitato di sentirsi rivolgere queste due parole, a cuore aperto. Ed è allora che ci si sente fortemente in contatto con quella persona, che si sente che ci sente, empatizza, e si realizza il mistero della connessione e qualcuno dice, si possono compire veri e propri miracoli.
Nel senso scientifico, invece questa parola, nel corso dei tempi e della storia è cambiata, vediamo quindi che interpretazioni sono state formulate.
Iniziamo con l’antica tradizione greca, a quel tempo la salute era concepita come un dono degli dèi e la malattia veniva considerata un fenomeno magico-religioso. La guarigione era considerata essenzialmente un fenomeno spirituale. Veniva associata alla dea Igea, i cui riti erano un segreto conservato dalle sacerdotesse.
Alla fine del II millennio a.C., tre ondate di invasori barbari imposero alla Grecia la religione e l’ordine sociale patriarcale. La maggior parte degli antichi miti della dea Igea furono deformati e cooptati nel nuovo sistema. Igea divenne figlia di Asclepio, Dio maschio più potente, e sorella di Panacea. Le due divinità rappresentavano differenti aspetti della salute, ugualmente importanti: Igea la prevenzione, ovvero la conservazione del benessere; Panacea la terapia, ovvero la cura dei mali. Ancora oggi abbiamo nell’ambito dell’architettura dei servizi questa distinzione.
Siamo nel 460 a.C. circa e con Ippocrate (460 a.C. circa 377 a.C.) cambiò del tutto la prospettiva secondo il principio, chiamato in seguito da Galeno «forza curatrice naturale», che concepiva il corpo umano animato da una forza vitale tendente per natura a riequilibrare le disarmonie causate dalle patologie. Secondo questa concezione, la malattia e la salute di una persona dipendevano da circostanze insite nella persona stessa, non da agenti esterni o da trascendenti interventi divini; la via della guarigione sarebbe consistita pertanto nel limitarsi a stimolare questa forza innata, non nel sostituirsi ad essa: «la natura è il medico delle malattie [...] il medico deve solo seguirne gli insegnamenti».
Esempi di questa tradizione di pensiero li vediamo per esempio nel digiuno, anche oggi praticato.
Prima dell’avvento della cultura classica non esisteva una scissione tra naturale e sociale, tra cielo e terra, tra unità e molteplicità, tra anima e corpo e quindi tra oggettività e soggettività. Questi elementi erano interconnessi in rapporti di scambio e di ambivalenza ed erano concepiti come parti di un’unità. Questa visione unitaria, era il nous. Afferma Galimberti che nelle società primitive non vi era mai un corpo, nella isolata singolarità, ma sempre un corpo comunitario, per non dire cosmico, dove avveniva la circolazione di simboli e dove ogni singolo corpo trovava, proprio in quella circolazione, non tanto la sua identità quanto il suo luogo.
Panacea la terapia, ovvero la cura dei mali.
Con il pensiero logico e la rappresentazione del corpo come entità anatomica, fu introdotta la logica disgiuntiva, che spezza metafisicamente cielo e terra, spirito e materia, anima e corpo. Questa distinzione fu introdotta da Platone, il quale delinea il sentiero che seguirà la tradizione giudaico-cristiana. La posizione di Platone si centra sulla distinzione tra anima e corpo e introduce la posizione dualista. Seguendo la logica che colloca la verità dell’essere nell’immutabilità del cielo, Platone definisce l’anima immortale, preesistente al corpo e immateriale, indicandola come principio della coscienza, del sentimento, della volontà e del pensiero. L’innalzamento dell’anima a vera essenza dell’uomo impone, per contrasto, la conseguente degradazione del corpo e la sua riduzione a puro strumento delle finalità dell’anima. Questa separazione mente corpo venne radicalizzata attraverso la ragione cartesiana, dalla quale è nato il pensiero scientifico in cui ancora oggi l’occidente si riconosce.
Nella Roma antica, secondo quanto attesta Plinio, il primo "medico" greco, proveniente dal Peloponneso, giunse a Roma nel 219 a.C.
Nacquero le prime università mediche e nel 1300 la scuola bolognese aprì la prima scuola di anatomia. La medicina medievale era un insieme di idee antiche e di influenze spirituali.
Nel Rinascimento la scienza medica pervenne gradualmente ad adottare una metodologia non più legata all'osservanza dogmatica degli scritti degli antichi maestri, Ippocrate e Galeno in primis, ma ispirata sempre più fortemente ai nuovi principi del metodo scientifico. Divennero quindi più stretti i rapporti tra medicina e le scienze naturali.
Nell'età moderna la medicina compie ulteriori passi sulla via dell'approccio rigorosamente scientifico, abbandonando definitivamente la matrice empirico-filosofica, approfittando anche dei progressi di altre discipline come fisiologia, biologia e chimica. Si passa così da una fase denominata da alcuni "medicina eroica", alla moderna medicina basata su prove di efficacia, contribuendo così, assieme ai miglioramenti nell'alimentazione e nell'igiene, alla diminuzione del tasso di mortalità, aumentando di conseguenza l'aspettativa di vita.
Alla fine del Settecento con la nascita della medicina scientifica, nasce il modello bio-medico, in concomitanza con la nascita della società industriale.
Nel XX secolo si sviluppano le prime specializzazioni mediche. Secondo alcuni autori, ciò avrebbe portato ad un graduale abbandono dell'approccio olistico alla persona ammalata a favore di uno studio esclusivamente biologico e mirato ad uno specifico organo o sistema. La salute viene definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)1 "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia", viene considerata un diritto e come tale si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che spettano alle persone. Questo principio assegna agli Stati e alle loro articolazioni compiti che vanno ben al di là della semplice gestione di un sistema sanitario. Essi dovrebbero farsi carico di individuare e cercare, tramite opportune alleanze, di modificare quei fattori che influiscono negativamente sulla salute collettiva, promuovendo al contempo quelli favorevoli. In una riunione dell'OMS del 1998 è stata proposta la modifica della definizione originaria del concetto di salute nei seguenti termini: «La salute è uno stato dinamico di completo benessere fisico, mentale, sociale e spirituale, non mera assenza di malattia.» 2
Avviandoci verso una conclusione, facendo una breve sintesi di quanto detto, possiamo affermare che abbiamo ordini maschili/femminili della cura. Abbiamo definizioni e configurazioni diverse della salute e della cura, nei tempi, da quelle più vicine agli dei, alla spiritualità, ai riti magico/religiosi; a quelle più vicine alla scienza, alla natura (le scienze -ica); altre che distinguono, disgiungono anima e corpo (anche giudaico cristiano), legate alla conoscenza esterna e logica dell’oggetto stesso (Linneo ..). Distinguiamo tra prevenzione/promozione e terapia. “Non basta porre la domanda: “Come stai?”, o parlare di Salute per essere in salute, occorre anche fare qualcosa per star bene, conservare quel bene o tornare, eventualmente, a stare bene. Oggi. Oggi la salute e la cura sono ritenute dei diritti per tutti, ma siamo in tanti. Ancora oggi si mantiene la dicotomia mente/corpo.
La salute è anche una responsabilità collettiva.
1 OMS World Health Organization, WHO; in francese Organisation mondiale de la Santé, OMS) è un istituto specializzato dell'ONU per la salute.
È stata istituita con il trattato adottato a New York nel luglio del 1946, entrato in vigore nel 1948 e ha sede in Svizzera, a Ginevra. Il 7 aprile è la Giornata
Mondiale della salute scelta dall'OMS anche per celebrare l'avvio delle proprie attività nel 1948. L'obiettivo dell'OMS, così come precisato nella
relativa costituzione, è il raggiungimento da parte di tutte le popolazioni del livello più alto possibile di salute, definita nella medesima costituzione
come condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto come assenza di malattia o di infermità. È membro del Gruppo per lo sviluppo delle Nazioni Unite.
2 La discussione, avvenuta nelle commissioni del WHA52, svoltosi dal 17 al 25 maggio 1999, non è arrivata all'Assemblea Generale. Conseguentemente è stato mantenuto il testo originario nonostante il voto favorevole della maggior parte dei rappresentanti dell'OMS stesso. Questo è avvenuto per diverse ragioni, tra cui aspetti linguistici, culturali e religiosi non universalmente condivisi. In tale contesto, la salute sarebbe stata considerata più un mezzo che un fine e avrebbe rappresentato una risorsa di vita quotidiana che consentisse alle persone di condurre una vita produttiva a livello individuale, sociale ed economico.