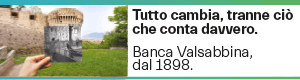Nikephobia o della paura di aver successo
Nikephobia (dal greco νίκη, vittoria, e φοβία, paura): così si definisce, o meglio, gli studiosi hanno definito la paura di vincere, un fenomeno noto a molti, ma che forse in pochi conoscono davvero
Di che si tratta? Si tratta di tutte quelle esperienze umane in cui risulta impossibile raggiungere i propri obiettivi, i propri traguardi, le proprie mete.
Pensate all’atleta che vince tutte le gare e poi, arrivato alla più importante, perde inspiegabilmente, come se non avesse più energie; oppure al musicista che stecca alla prima, nonostante mesi di prove ed esibizioni.
O ancora, allo studente che si prepara con grande dedizione per l’esame, ma in sede d’esame non ricorda concetti che fino al giorno prima snocciolava con facilità, come fossero delle arachidi a un aperitivo.
Allo studioso che, pur avendo tutti i titoli per trionfare, non partecipa alle prove idonee per entrare di ruolo.
Al manager che, raggiunta la meta, inizia a vacillare in termini di sicurezza.
All’imprenditore che commette un errore banale, compromettendo una grande impresa.
Per non parlare della persona che rinuncia al grande amore, nonostante abbia sognato per una vita di realizzarsi in campo sentimentale.
Tutti questi sono solo alcuni esempi di come la prospettiva di un successo futuro possa provocare così tanta paura da portare l’individuo ad autoboicottarsi poco prima di raggiungerlo o subito dopo averlo conseguito.
Il fenomeno non riguarda solo chi raggiunge traguardi elevati, e non si riferisce unicamente a personalità di spicco: coinvolge tutti noi quando desideriamo fortemente raggiungere un obiettivo, che sia professionale, sportivo, artistico o affettivo/sentimentale.
Ma perché accade tutto questo?
Il senso comune dice che quella persona non ragiona bene, che pecca di logica.
La scienza, invece, sa che la paura di vincere può minare il successo stesso; in tal senso perturba il senso comune, sfidando i principi rassicuranti del pensiero logico-razionale, e avanza molte ipotesi teoriche.
Vediamo, brevemente, quali teorie ci possono aiutare a capire meglio — e, quindi, a trovare soluzioni.
Innanzitutto, c’è una teoria di frontiera tra organismo e mente: la teoria del meccanismo difensivo dell’omeostasi (dal greco στάσις, l’essere fermo, stabile), osservata e formulata nel 1859 dal fondatore della moderna fisiologia, Claude Bernard.
Secondo questo studioso, la paura di vincere coincide con un meccanismo biopsicologico naturale, che genera veri e propri cortocircuiti emotivi a fronte di cambiamenti importanti.
La psicoanalisi interpreta tutto questo attraverso le dinamiche distruttive presenti nell’individuo.
Leon Festinger (1953), un cognitivista, ha formulato la teoria della dissonanza cognitiva, dimostrando, attraverso ripetuti esperimenti, come di fronte a ogni scelta di cambiamento si attivino nella mente dell’individuo due forze psicologiche contrastanti: una che spinge in avanti e una che frena.
Ovvero: da una parte il soggetto pondera e cerca conferme dei vantaggi del cambiamento, dall’altra la sua mente riflette sui pericoli e sui possibili effetti negativi.
È importante evidenziare che tutto ciò si verifica a livello emotivo, non come un atto deliberato: la resistenza al cambiamento, dunque, risulta il più delle volte inconsapevole e può influenzare pesantemente l’agire umano, rappresentando un processo fuori dal controllo razionale.
Nella prospettiva cognitivo-comportamentale, questo apparente paradosso può essere compreso solo se si considera che la paura è la nostra emozione primaria più potente, in grado — se attivata prepotentemente — di inibire non solo le altre emozioni fondamentali (piacere, dolore, rabbia), ma anche le capacità cognitive, dominando così le nostre reazioni.
Per cui, quando la paura aumenta vertiginosamente, a un passo dal raggiungimento del risultato tanto desiderato, il soggetto si ritrova come imprigionato, incapace di esprimere al meglio le proprie competenze.
Noi diciamo che va considerata ogni singola situazione, va compreso l’oggetto dell’indagine, per scegliere la teoria più valida — non solo per capire, ma per tentare di fare qualcosa.
Questo perché il mancato raggiungimento di un traguardo può generare più sofferenza della rinuncia a perseguirlo.
Dobbiamo riconoscere che la mente è ampia e discorsiva: non sempre formula pensieri coerenti, non sempre la narrazione coincide con l’azione o con il sentire. Ed è per questo che si verificano certi accadimenti.
Come uscirne?
Un percorso terapeutico può rivelarsi utile, sia prima delle prove — per superare eventuali resistenze al cambiamento, per oltrepassare certi vissuti emotivi, per rendere tutto più congruente e fluido — sia durante, favorendo quelle condizioni ottimali che portano alle cosiddette peak experience: stati di coscienza in cui tutto scorre con naturalezza, e si riesce a realizzare con facilità, gioia e serenità, senza più doversi affidare unicamente alla forza di volontà.