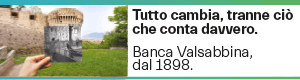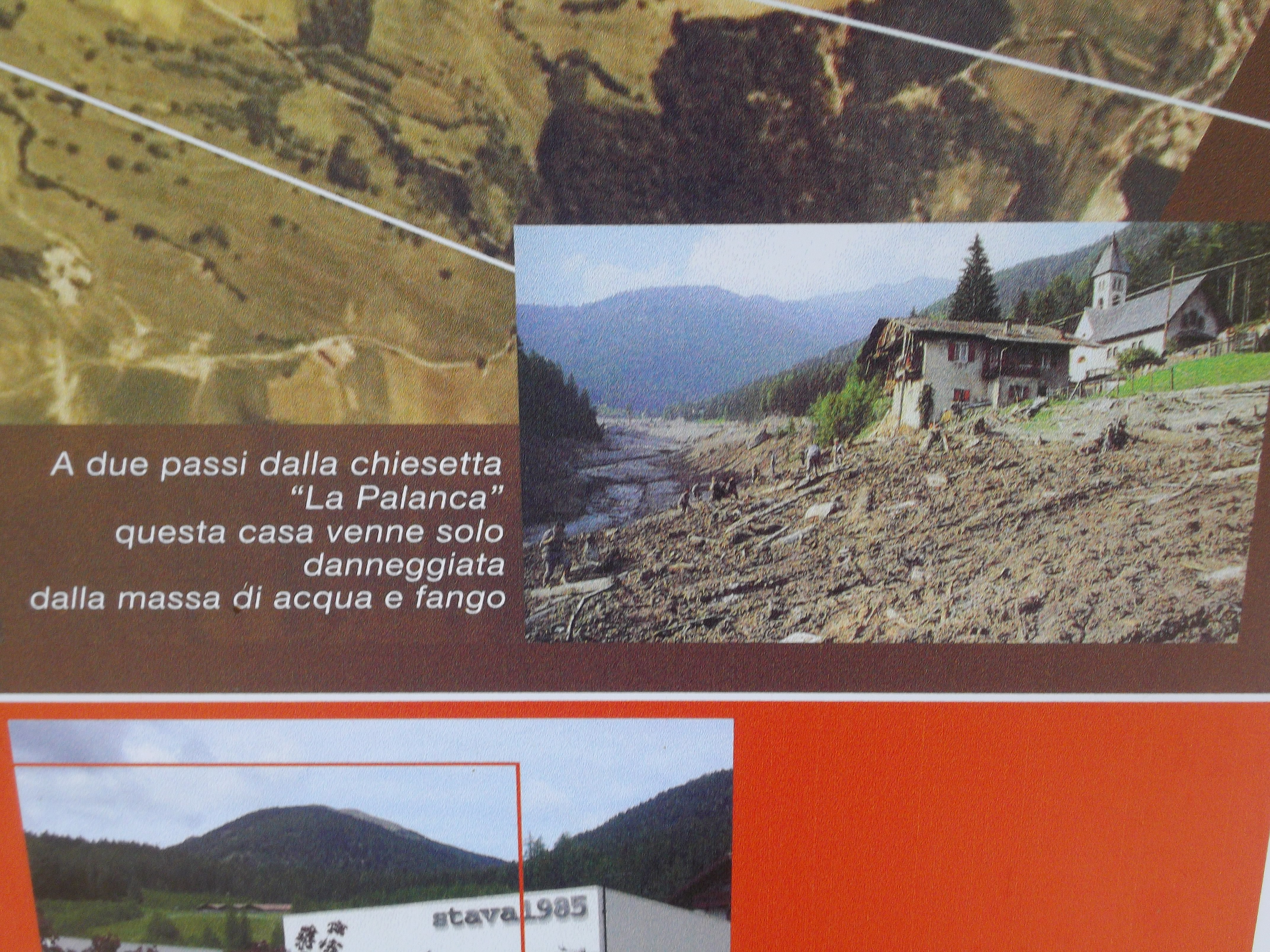L'eremo che canta leggende di santi e gesta di paladini
Frammenti di letterature provenzale nel cuore della pianura
Da più di un’ora viaggio attraverso la Lomellina, fertile terra circondata dalle acque del Po, del Ticino e della Sesia, ricca di riso, frumento, ortaggi e terreni coltivati a marcite.
La monotonia del paesaggio, pur nella sua sterminata bellezza, viene all’improvviso ad ammantarsi di fascino quando giungo nei pressi di Mortara, in quella zona che i Longobardi elessero a residenza estiva dei propri sovrani e dei notabili del regno.
Proprio qui sorgeva la leggendaria città di Pulchra Sylva (Bella Foresta), il cui ultimo destino si compì sotto Carlo Magno.
Fu qua, infatti, che nel 773, sotto le mura del villaggio, che con il rosso dei suoi mattoni, spiccava nel verde della campagna, si combatté una grande battaglia tra Franchi e Longobardi. La vista terribile di quella carneficina cambiò il toponimo della località. Pulchra Sylva divenne la Mortis Ara (l’altare della morte), da cui Mortara.
Affascinato da questi leggendari racconti, parcheggio l’auto proprio nei pressi di uno di quei prati le cui zolle trasudano il sangue di quel cruento, lontano scontro. Un sentiero a lato della strada statale, discende lievemente verso i campi e termina in uno spiazzo ombreggiato da pioppi imponenti.
Ecco quasi magicamente emergere, malinconico, dal verde della pianura un sacro edificio medioevale, scrigno prezioso di leggende e di storia.
È l’Abbazia di Sant’Albino, gioiello dell'architettura religiosa del XII secolo, che sorge solitaria nella vasta distesa dei campi, con l'elegante campanile cuspidato e il leggero, sobrio protiro a colonnine di granito.
Prima di questa abbazia sorgevano nella zona fin dal IV secolo due chiese che il vescovo di Novara, Gaudenzio, aveva fatto costruire alle porte di Mortara; l’una dedicata a Sant’Eusebio e l'altra a San Pietro.
Una gentilissima signora viene ad aprirmi il portale e lascia che da solo visiti l’interno dell’abbazia.
Semplice e ad aula unica con abside semicircolare, essa è caratterizzata dagli affreschi del presbiterio e dai mattoni che portano incise le tracce dei numerosi pellegrini che tra l'XI e il XIV secolo sostarono in Sant'Albino.
Sulla parete destra della navata, una nicchia protetta da una grata attira la mia attenzione e spalanca le porte della leggenda e del mistero.
Al suo interno, infatti, è conservata un’urna contenente alcune ossa. Di che si tratta?
Nel 1928 furono scoperti, sotto l'altare dell’abbazia, due cunicoli sovrapposti. In quello superiore furono trovati un teschio e alcune ossa, in quello inferiore resti ossei e quattro dischetti metallici.
Le analisi scientifiche sui suddetti reperti stabilirono una datazione di almeno 1000 anni. Ciò li farebbe risalire a un periodo molto vicino alla battaglia di Pulchra Sylva.
È necessario a questo punto fare un salto in quella Storia che sconfina nella leggenda ed approfondire i racconti e le tradizioni nate intorno ad alcune figure mitiche e storiche allo stesso tempo.
Per cominciare cerchiamo di conoscere i personaggi che hanno reso speciale questo luogo, a cominciare proprio da Albino Alkwin, il cui nome fu italianizzato in Flacco Albino. Veniva dall'Inghilterra e precisamente dalla contea inglese del Northumberland, dove era nato nel 735. Divenuto monaco, sembra sia stato lui a suggerire la costruzione dell’abbazia in seguito a un evento miracoloso e a divenirne poi abate.
Il 12 ottobre 773, la battaglia di cui parlavo, si combatté nella zona in cui si trovavano le due chiesette di Sant’Eusebio e di San Pietro.
Nella contesa morirono anche due eroici e fidati paladini di Carlo Magno, Amelio d’Alvernia e Amico Beyre.
Per volere della Regina, su invito del monaco Albino, i due eroici combattenti furono sepolti insieme sul luogo della battaglia: Amelio in Sant'Eusebio, Amico in San Pietro.
Se qui termina la storia, non così per la leggenda, che prende vita proprio dalla storia stessa.
Si racconta, infatti, che il giorno dopo, sotto l'altare della chiesa di Sant'Eusebio, le spoglie di Amelio e quelle di Amico furono ritrovate l'una accanto all'altra. Fu la straordinarietà di questo episodio a convincere Albino a fondare in quel luogo un monastero che inglobasse la chiesa di Sant'Eusebio. E quando Albino venne nominato vescovo di Vercelli, i suoi allievi proseguirono nella guida del monastero da lui fondato.
Alla sua morte, avvenuta nell'801, Albino chiese di esser sepolto al cenobio di Mortara, vicino ad Amico e ad Amelio.
Ma chi erano questi due leggendari paladini di Francia?
Amico, figlio di guerrieri, e Amelio, figlio del conte d’Alvernia, sarebbero nati lo stesso giorno. Si racconta che, oltre ad essere amici fidati, si assomigliassero come due gocce d'acqua e che il loro destino fu quasi deciso dalla comunanza di scelte e di azioni.
Entrambi pellegrini, si conobbero a Lucca e decisero di comune accordo di fare vita cenobitica. Battezzati a Roma dal Papa, in seguito presero strade diverse, sapendo che un giorno il destino li avrebbe fatti nuovamente incontrare.
Così fu. Anni dopo si ritrovarono presso la corte di Carlo Magno; Amico come tesoriere ed Amelio come coppiere. Presero attivamente parte alla guerra franco-longobarda e così come il destino li aveva fatti nascere nel medesimo giorno, anche la morte li rapì entrambi nel corso della battaglia.
Ancora oggi, accolti e coccolati dalla spiritualità campestre del luogo, molti francesi visitano l’abbazia di Sant'Albino per rievocare l'epopea carolingia.
Io, nella quiete agreste di un mattino estivo, ho trovato in questo scorcio di Via Francigena, i ricordi lasciati alle pagine degli studi scolastici, integri e vivi tra le pietre della religiosità, rapiti dal vento leggero e delizioso della leggenda.
“Giunti a Mortara, quivi udimmo a pieno
che per i molti morti il nome prese,
quando li due compagni vennon meno”.
(Fazio degli Uberti, Dittamondo, III, 5)