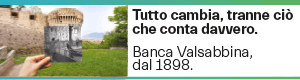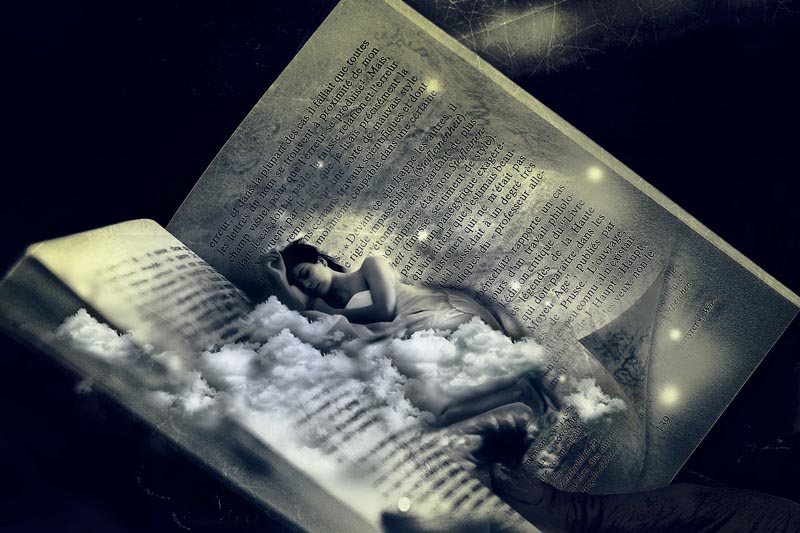L’effetto Barnum e altri bias
“Ma parla di me?!” (...o magari non sei così speciale) – come relazioniamo ogni cosa a noi stessi
L’ampio riscontro a cui va incontro un gran numero di pseudoscienze è da lungo tempo oggetto di fascino: se vi è mai capitato di svolgere dei test della personalità, vi sarete possibilmente stupiti dell’accuratezza dei risultati ottenuti, anche per banalità come “che merendina sei?” è facile pensare qualcosa come: “sì, effettivamente il plumcake mi rappresenta!”.
Se l’esempio è troppo di nicchia, basti pensare all’oroscopo, che sembra sempre inquadrarci troppo accuratamente, oppure ai biscotti della fortuna, che ci rivelano piccoli messaggi positivi con un tempismo quasi provvidenziale.
Questa peculiare ricorrenza venne analizzata da un punto di vista psicologico già nel '900 dallo psicologo Bertam B. Forer, che la introdusse come fallacy of personal validation (fallacia nella valutazione personale), poi denominata "effetto Barnum" dallo psicologo Paul Meehl, in nome del noto imprenditore circense Phineas Taylor Barnum, conosciuto per le mistificate bizzarrie che era solito proporre nei suoi spettacoli.
Nel 1948, Forer presentò ai suoi studenti di psicologia una lista di 13 tratti caratteriali estrapolati, a detta sua, da ogni studente in base ad osservazioni su un test precedentemente svolto ma, all’insaputa dei riceventi, i tratti elencati erano gli stessi per ogni scheda.
Ecco un campione della lista:
(1) Hai un grande bisogno di piacere ed essere ammirato dalle altre persone.
(2) Hai la tendenza ad essere critico verso te stesso.
(3) Hai un gran numero di capacità che non hai utilizzato a tuo favore.
(4) Seppur tu abbia alcune debolezze nella personalità, sei generalmente in grado di compensarle.
Suonano familiari?
Le schede presentavano istruzioni per valutare su una scala da 1 a 5 quanto le affermazioni fossero attendibili e veritiere secondo i riceventi.
In media, il punteggio risultò 4.3/5, indicando un sorprendente consenso generale.
Oltre che a mettere in discussione le procedure e gli elenchi della diagnostica e della pseudo-diagnostica, Forer diede rilevanza alla questione dell’impressionabilità umana e dell’influenza che avesse su questa la fiducia nel valutatore, argomento che riacquistò rilevanza con il noto esperimento Milgram nel 1961, che aveva lo scopo di studiare il comportamento di individui di fronte all’autorità.
L’effetto Barnum descrive dunque l'immedesimazione da parte di individui in descrizioni vaghe, esperienze condivisibili da pressoché chiunque ma che paiono riferirsi personalmente a loro, nonostante risultino valide per la maggior parte delle persone. Il fenomeno è strettamente legato al concetto di “convalida soggettiva” (subjective validation o personal validation effect), un’altra forma di bias cognitivo per cui un individuo sarebbe più propenso ad accettare un'informazione come vera quando ci trova della rilevanza a livello personale. Ma perché “vogliamo” crederci?
Probabilmente le cause riguardano una questione di autostima, già osservata da Forer e riportata nella relazione del suo esperimento: quando l’autostima di un individuo è minacciata, la memoria verrebbe distorta per deviare il pericolo e riconsolidare la propria immagine.
Si può pensare al self-serving bias (detto anche bias di autoprotezione), ossia la tendenza ad attribuire i successi a qualità personali e i fallimenti a forze esterne e incontrollabili o a “circostanze sfavorevoli”. Questo bias potrebbe essere rafforzato da quello di conferma, ovvero la tendenza ad interpretare e assimilare informazioni in un modo che supporti o confermi le proprie credenze, sia positive che negative.
Un’altra abitudine a cui siamo particolarmente legati è quella del generalizzare e categorizzare: è conveniente e appetibile nascondersi dietro a delle etichette che, seppur limitando la nostra espressione individuale, compensino col senso di appartenenza a un gruppo e l’inestimabile sicurezza dell’“anonimato”.
Sicuramente è prominente anche il desiderio di credere di getto alle informazioni che ci vengono presentate come fatti, in particolar modo quando queste sono divulgate da figure autoritarie o competenti in un determinato settore, che diventano valide proprio grazie al valore idealizzato che viene attribuito loro.
È necessario prendere coscienza dell'influsso della nostra soggettività nell’internalizzare e interpretare determinate informazioni, altrimenti è significativamente più facile abboccare a intenti propagandistici o seguire solo un’immagine costruita interiormente di ideali portati avanti da un’agenda.
Analizzando i diversi modi in cui siamo propensi a distorcere inconsciamente i fatti e riconoscendo l'ampio margine di errore a cui siamo soggetti, si può sviluppare il proprio pensiero critico e una visione più eclettica della realtà osservabile.
Illari Sofia Pizzoni, 5A Liceo