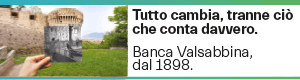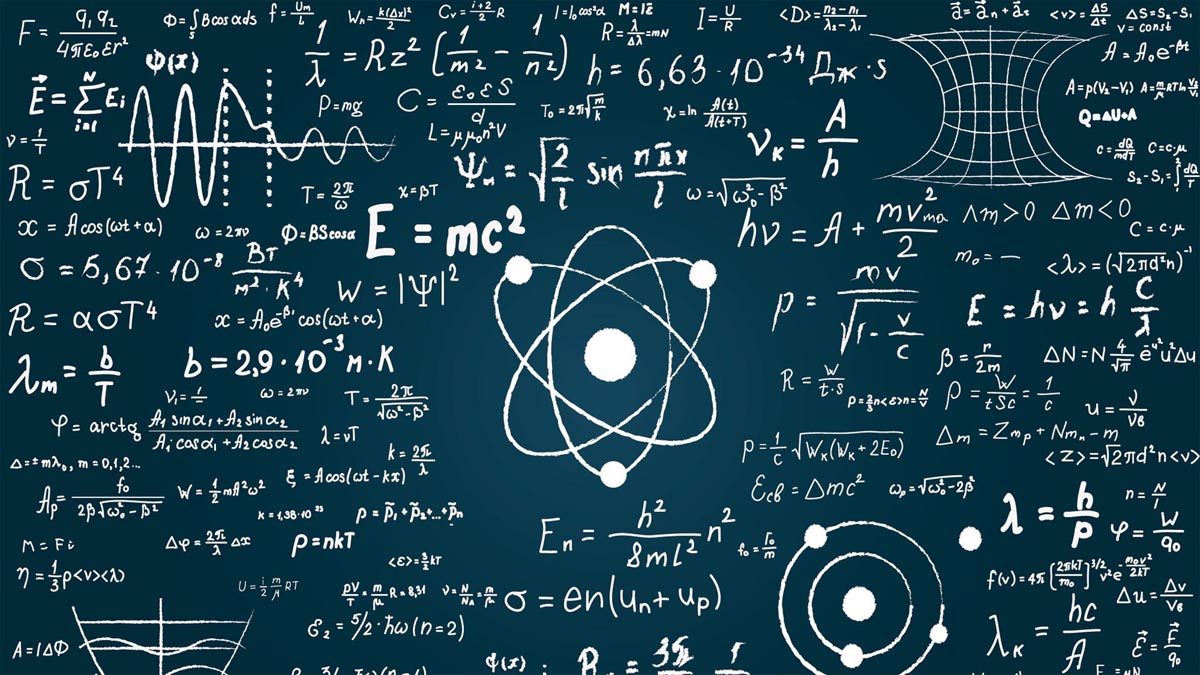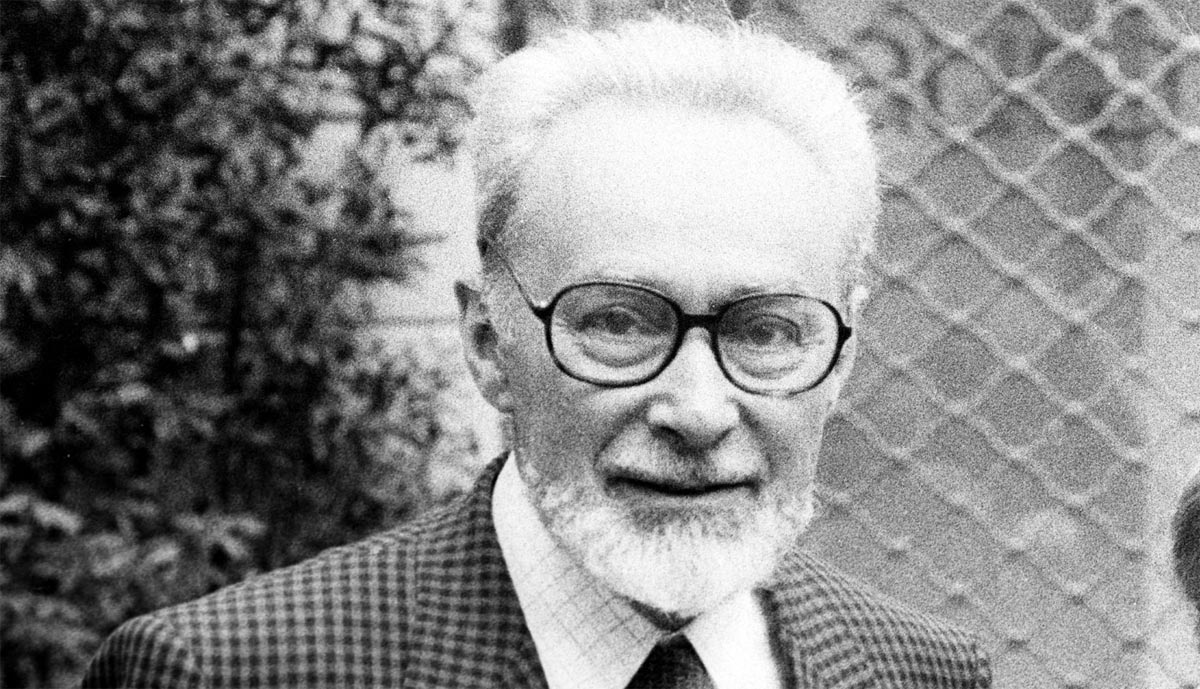La nascita della meccanica quantistica
“La fisica non è una rappresentazione della realtà, ma del nostro modo di pensare ad essa” Werner Karl Heisenberg
Il 4 e 5 febbraio 2025 a Parigi, presso il Quartiere Generale UNESCO, si è tenuta la cerimonia di apertura dell’Anno Internazionale delle Scienze e delle Tecnologie Quantistiche, celebrando così i 100 anni dalla nascita della meccanica quantistica, elaborata nel 1925 da Werner Karl Heisenberg, Max Born e Pascual Jordan (meccanica delle matrici) e in parte da Erwin Schrödinger (meccanica ondulatoria).
La meccanica quantistica è la teoria fisica che si occupa di descrivere e spiegare i fenomeni atomici e subatomici in termini di probabilità statistica.
Si tratta di una teoria così paradossale che pure chi la inventò rimase stupito. Si scoprì che il comportamento di una particella non era prevedibile con esattezza, ma solo in modo probabilistico: per esempio, se consideriamo un atomo di uranio, sappiamo che emetterà radiazioni, ma non quando.
A questo proposito interessante è il paradosso del gatto di Schrödinger, un esperimento mentale che il fisico ideò nel 1935: in una scatola chiusa ci sono un gatto, una fiala di veleno, una fonte radioattiva (uranio) e un martello.
Nella scatola è presente un meccanismo per cui, se la fonte radioattiva decade, viene emessa una radiazione che genera un effetto a catena per cui il martello rompe la fiala di veleno, uccidendo il gatto. Vi è un 50% di possibilità che il gatto sia vivo, ma questo non potremo saperlo fino a quando non apriremo la scatola.
L’effetto risulterà assurdo: per noi il gatto è sia vivo che morto fino a quando non compiamo l’osservazione.
Un altro banale esempio può essere quello di tenere una mela davanti a voi e di chiudere gli occhi.
Se vi dicessi che la mela nel frattempo è andata fino alla luna e poi è tornata nella sua posizione originale, mi credereste? Probabilmente no, ma non potreste nemmeno provare il contrario.
Questo è quello che accade a livello subatomico, una volta osservata una particella in una determinata condizione non si può dire che si troverà nella stessa subito dopo. Su questo si basa il principio di indeterminazione di Heisenberg, con il quale il fisico stabilì l’impossibilità di misurare con certezza e con simultaneità le proprietà che definiscono lo stato di una particella elementare.
Nonostante la nascita ufficiale di questa materia venga collocata nel 1925, è importante sottolineare che formulare questa teoria è stato possibile solo grazie agli studi di Einstein e Planck, i padri della fisica quantistica, risalenti ai primi anni del XX secolo.
Fu proprio Planck ad elaborare la teoria dei quanti (da cui prende il nome questa branca della fisica), presentando l’ipotesi che l’energia non venga emessa in un flusso continuo, come l’acqua che scorre da un rubinetto, ma in “quanti”, cioè piccoli pacchetti di energia.
Uno potrebbe giustamente chiedersi, a questo punto, se la fisica quantistica e la meccanica quantistica non siano la stessa cosa.
Per essere precisi, quando parliamo della prima ci riferiamo all’insieme di principi e di leggi che descrivono i fenomeni quantistici in generale, pertanto vi è inclusa anche la meccanica quantistica, che invece definisce lo studio dell’infinitamente piccolo.
Einstein odiava con tutto il cuore la meccanica quantistica, nonostante egli avesse contribuito, anche se indirettamente, alla sua elaborazione grazie alle leggi della relatività ristretta e generale; in particolare in una lettera a Max Born del 4 dicembre 1926 scrisse “Io, in ogni caso, sono convinto che (Dio) non giochi a dadi”.
Niels Bohr gli rispose “Einstein, smettila di dire a Dio quello che deve fare”.
Questo suo astio per la materia fu visibile anche nel congresso di Solvay del 1927.
Per chi non lo sapesse, questi congressi vengono organizzati ogni 3 anni (con il primo nel 1911) e riuniscono le menti più geniali del mondo, che si ritrovano per discutere e stimolare il progresso scientifico.
In particolare, nel 1927 il tema scelto fu quello di “elettroni e fotoni” e dire che questo congresso fu infuocato è un eufemismo. Ricordando che due anni prima era nata la meccanica quantistica, i fisici si erano divisi in due parti, chi riteneva valido il principio di indeterminazione e chi no, tra cui rispettivamente Bohr e Einstein.
Durante il congresso i due discussero continuamente: ogni mattina Einstein era pronto a proporre un esperimento mentale a Bohr per provargli di aver ragione e Bohr ogni giorno riusciva a smentirlo, utilizzando anche la teoria della relatività di Einstein. È importante dire che il dibattito avveniva tra due fisici che si stimavano, il cui scopo non era tanto quello di confutare le idee uno dell’altro ma di arrivare alla verità.
Rendiamoci conto di quale impatto questa teoria abbia avuto sulla società novecentesca: determinava il crollo di tutte le teorie della fisica classica, dell’interpretazione dell’universo in termini meccanicistici, deterministici e sorgeva una nuova realtà governata dalla probabilità.
“Ogni grande e profonda difficoltà porta in sé la sua soluzione. Ci costringe a cambiare il nostro modo di pensare per trovarla”.
Niels Bohr
Pelizzari Manuela, 5 AL