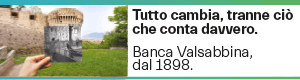Dove l’acqua custodisce il silenzio
Tra le brume della pianura, accanto alla roggia Cremasca, un piccolo tempio veglia su memorie d’altri secoli. Voci perdute, ossa ritrovate, lapidi che chiedono preghiere: e nell’aria immobile, il tempo si fa pietà
Al confine tra il comune di Crema e quello di Bagnolo Cremasco, accanto al ponte della Cremasca in sponda sinistra, ecco apparirmi una di quelle costruzioni che, se potessero parlare, racconterebbero storie di dolore, morte, redenzione e pietà.
È il tempietto dei “Morti delle Tre Bocche” che ho casualmente incrociato in un fresco mattino di settembre, a Ombriano, nel cuore della Pianura Padana.
Una costruzione semplice, ma dalle linee eleganti: un cortiletto cinto da un porticato ovale con un alto portale sovrastato da un cornicione curvilineo. Dall’ingresso si dipartono le due braccia porticate dalle forme baroccheggianti, che si ricongiungono alla cappella posta sul fondo in asse con l’arcone d’ingresso.
Scopro che questo interessante manufatto fu eretto agli inizi del Settecento per volere del principe Eugenio di Savoia allo scopo di accogliere i corpi di ventisei soldati austriaci, ungheresi e prussiani, appartenenti al suo esercito.
Si era durante la Guerra di Successione Spagnola (1701-1714); il 16 agosto 1705, nella battaglia di Cassano d’Adda, combattuta tra le truppe austroungariche del generale conte Von Leiningen agli ordini del principe Eugenio di Savoia, e quelle franco-spagnole guidate dal maresciallo Vendome, nel tentativo di forzare l’Adda, alcuni soldati annegarono.
I loro cadaveri, trascinati dalle acque, giunsero fino al nodo idraulico detto “delle Tre Bocche” e vennero trattenuti dai piloni e dalle grate che proteggevano le chiaviche.
I contadini del posto, in nome di una pietas che non conosce nazionalità, pensarono bene di dar loro degna sepoltura.
Successivamente, per volontà di Eugenio di Savoia, si andò a modificare quello che era un edificio già esistente, probabilmente in epoche passate adibito a lazzaretto, come conferma l’iscrizione sovrastante l’ingresso principale.
All’interno della cappella spiccano la statua del Cristo morto, posta in una teca di vetro, sotto l’altare, e l’affresco della Madonna del Carmine, in cui, sullo sfondo sono ben riconoscibili la roggia Cremasca con il Ponte delle Tre Bocche affiancato dall’ossario, e a destra una chiesa con campanile.
Commoventi sono le scritte ai lati dell’ingresso, dove l’invito alla preghiera dei vivi è affidato alla volontà degli scomparsi:
“Tanto più meritoria sarà la vostra preghiera per noi perché vi siamo sconosciuti tanto più sarà gradita a Dio perché siamo abbandonati”.
“Il fuoco ci colse, l’acque ci travolse, schiudeteci o pietosi l’eterno refrigerio”.
Gli affreschi nelle braccia porticate creano un’atmosfera di terrore e meditazione della pietà popolare nei confronti della morte.
Gli scheletri (sei in tutto) sono vestiti con particolari riferiti alle uniformi dei soldati settecenteschi (parrucche, cappelli, insegne ed armi).
Tali raffigurazioni, dette “della morte secca” sono curate nei particolari; oltre, infatti, a rimandare a divise e stendardi dell’epoca, rimandano anche alle armi cui i singoli caduti appartenevano.
Quattro semplici teche, sempre nel portico, contengono i resti ossei dei soldati ivi sepolti.
Le memorie d’oltretomba in luoghi di forte impatto evocativo come questo di Ombriano, fanno vibrare le corde dell’animo romantico, come succedeva a Chateaubriand e come succede ai veri spiriti nobili.
Si uniscono al ricordo di questi eventi lontani anche due lapidi commemorative dei caduti di Ombriano nelle due guerre mondiali. Così la memoria di vicende remote si congiunge a quella del passato più recente in un’unica opera di pietà e di commemorazione.
E intanto l’acqua della roggia cremasca continua a scorrere a fianco del tempietto e a lambirne i silenzi. Bandiere italiane e austriache sventolano sul pennone in un abbraccio di pace e di speranza.