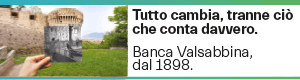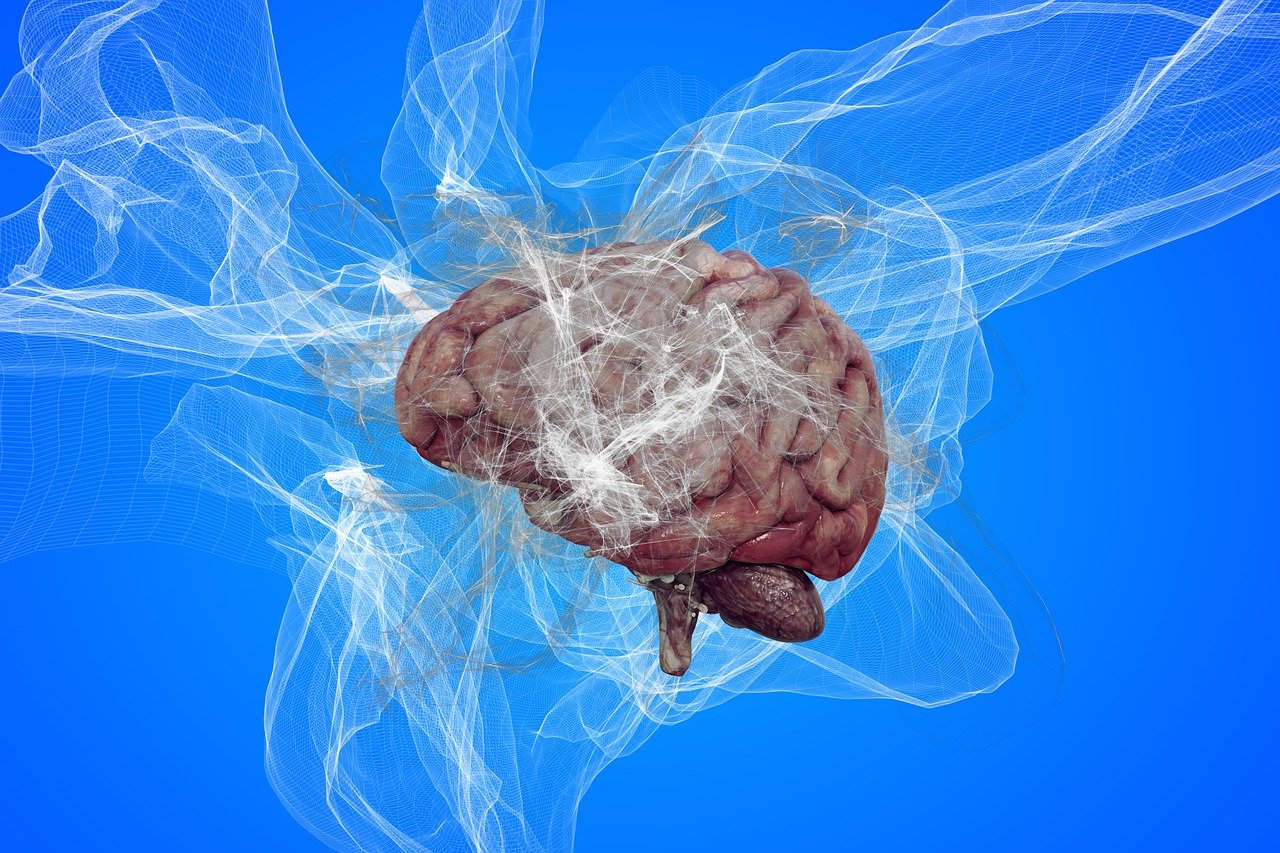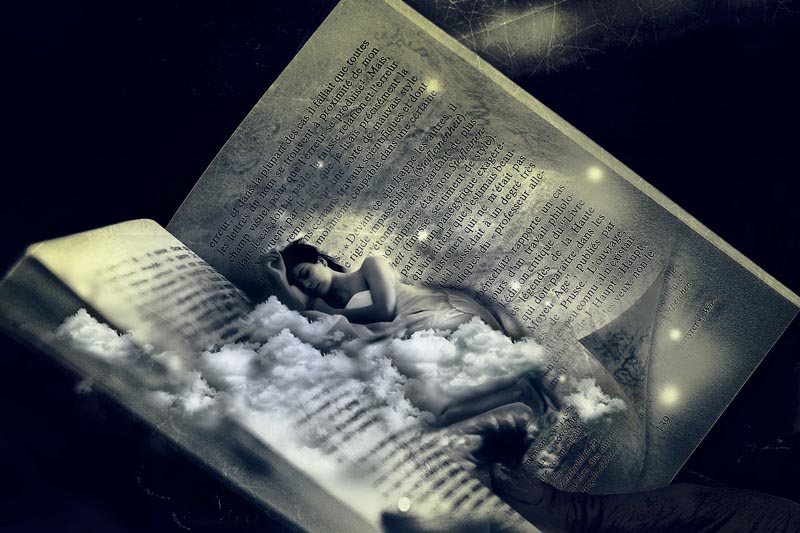Marciume cerebrale
Ci troviamo immersi in un mondo incapace di stare in silenzio, ma se il silenzio sapesse urlare?
“Brain rot”, dall’inglese “marciume cerebrale” è stata l’espressione con cui i linguisti di Oxford hanno voluto chiudere il 2024.
È interessante notare che sia stata necessaria la creazione di un neologismo per esprimere gli effetti del bombardamento multimediale di cui sentiamo spesso, forse troppo spesso, parlare: siamo ormai entrati nell’ottica che un mondo costellato da notizie lampo, start up che crescono come funghi e la percezione che tutto sia incredibilmente accessibile e veloce, sia ormai la nostra quotidianità; tutto questo senza avere la più pallida idea di come ci siamo finiti.
“Viviamo in un mondo che corre” è diventato lo slogan che oserei designare come il più celebre di questi “tempi moderni”, preso in prestito sia da chi muove le critiche, che da coloro che esaltano il mito del progresso e, vista la foga con cui ci affanniamo a inseguirli, è un peccato che non si tratti del sequel dell’omonimo lungometraggio di Charlie Chaplin del 1936: sicuramente lui ne sarebbe stato più felice.
uttavia, il mondo è mosso, oltre che dall’elettricità e dal petrolio, anche da una buona quota di indolenza e, in nome di questa, aggiungerei una piccola postilla al motto del XXI secolo: corriamo tanto, il che va bene, ognuno ha le sue ragioni, chi per perdere qualche chilo e chi inseguito da un serial killer, ma, tolte queste due categorie giustamente esonerate dalla menzione, sarebbe troppo chiedere dove accidenti siamo diretti?
Ora, se qualcuno sa dirmi dove, a meno che non sia verso un muro in cemento armato, perché ci ho già pensato io, sarei sinceramente felice se me lo faceste sapere, così da poter far ritrovare la pace dei sensi alla mia generazione senza dover fare necessariamente ricorso all’uso di cospicue dosi di melissa e valeriana.
Se queste poche righe vi hanno fatto sorridere, bene, ho raggiunto il mio intento: vi ho fatto credere che, tutto sommato, si possa andare avanti anche così.
Questo è il modo in cui funziona la nostra società moderna, in cui quasi nessuno ha più la tempra – perché la voglia si era già esaurita – di vivere lucidamente nel mondo in cui siamo.
Troppo dolore, troppe guerre e dall’altra parte troppa frivolezza, troppa spensieratezza: beh, se il giusto sta nel mezzo, forse dobbiamo renderci conto che in mezzo noi non ci sappiamo stare. Per lo meno non ancora.
Non sappiamo più se essere spensierati o disperati, se porgere la mano con sincerità o nascondere un pugnale nell’altra, se avere paura di tutto o vivere come se dovessimo morire domani.
No, aspettate, domani è troppo lontano: siamo esseri molli, con i cervelli in putrefazione – menomale che a Oxford se ne sono resi conto! – chi ce la fa a resistere, vivo, lucido, cosciente, senza sentire il bisogno di spegnere il cervello affogando i neuroni nella TV spazzatura o nei reel sui social media.
Noi non sappiamo se avere paura di tutto o se fare come se la paura sia il nostro stato fondamentale.
Una cosa curiosa è che tanti pensano che questo sfacelo sia iniziato quando è stato inventato il cellulare: con buona pace delle mamme che lo ripetono fino allo stremo, ebbene avete indovinato.
Non tanto perché quell’aggeggio contenga in sé tutti i mali dell’universo - quello era il vaso di Pandora, non facciamo confusione - bensì perché ha esponenzialmente accelerato la diffusione di qualsiasi contenuto, rendendo il web più pericoloso della combinazione scoglio-petroliera. Oppure di quella Einstein-nucleare.
Per quanto possa sembrarvi assurdo, specie a chi di voi è genitore, se la soluzione a tutto questo fosse gettare i cellulari nel primo buco nero a disposizione, molti di noi ragazzi ne sarebbero felici.
Sono innumerevoli le ricerche scientifiche che stanno portando alla luce i danni prodotti dalle nuove tecnologie sull’essere umano, a cominciare dalla postura e andando a finire alle capacità cognitive, e il quadro sia aggrava maggiormente con l’abbassarsi dell’età a cui i bambini vengono esposti ai videoterminali, perciò, potendo, ci terremmo a conservare qualche neurone.
Se la soluzione stesse qui, allora avrebbero ragione coloro che si fanno paladini del motto “Si stava meglio quando si stava peggio!”, peccato che quando si stava peggio, ossia meglio, prima di poter chiedere aiuto, se sfortunatamente eri vittima di violenza domestica, sarebbe passato molto tempo, forse troppo, oppure, prima di essere operato di appendicite in laparoscopia, con una procedura ambulatoriale, ti saresti ritrovato con una cicatrice di quindici centimetri dopo dodici ore di operazione.
“In medio stat virtus”: la virtù sta nel mezzo e forse noi dobbiamo cominciare a ricalcolare, al posto dei chilometri orari, il baricentro della nostra società, sulla base delle dismetrie che ha assunto ognuno di noi.
È banale affermare che l’unica cosa che possiamo controllare a questo mondo sia la nostra persona, la nostra mente: ce lo ripetono da sempre coloro ai quali è stata detta la medesima bugia, non tanto perché ci sia qualcos’altro da controllare, ma perché quando crediamo di avere la nostra mente in tasca, ecco che questa decide di farci vedere di cosa è capace.
E difficilmente gonfierà palloncini e sparerà fuochi d’artificio. Dunque, che fare? Vorrei avere la verità in tasca, ma senza la testa diventa difficile.
Justin Welsh affermava che “il lusso moderno è la capacità di pensare lucidamente, dormire profondamente, muoversi lentamente e vivere tranquillamente in un mondo progettato per prevenirli tutti e quattro”.
Alla luce di queste parole, l’unico modo che vedo per lasciare il mondo meno confuso e rottamato di come lo abbiamo trovato è proprio uscirne, sottrarsi al condizionamento che esso esercita su di noi ed analizzarlo, senza però dimenticare come sia starci dentro, perché se è vero che non dobbiamo lasciarci andare allo sconforto, è altrettanto vero che solo grazie a questo riusciamo a prendere coscienza della mole di un problema e del suo impatto su noi stessi.
A ritrovare il gusto di fare quello che ci piace e non quello che ci hanno fatto piacere.
Walter Benjamin, uno dei più grandi filosofi che la storia abbia conosciuto, scrisse che “la speranza appartiene a chi non ce l’ha”: non possiamo affrontare qualcosa senza che essa ci abbia almeno parzialmente annientati, solo dai nostri frammenti possiamo ricostruirci rinforzando le nostre crepe – e non mascherandole, perché tutti abbiamo capito, padri di famiglia in primis, che il silicone non va usato per riparare i vasi di porcellana, vero?
A chi crede che questa non sia la sua battaglia, perché magari ha passato una certa età e crede che solo i giovani possano essere il futuro, o ai giovani stessi che si sentono sfiduciati o addirittura indifferenti verso l’insofferenza che costantemente abitano, la quale è alimentata dall’indifferenza stessa di cui noi tutti ci nutriamo, vorrei dire che sì, magari in futuro saremo noi a dover continuare a lottare, ma se noi siamo il futuro, tutti insieme siamo il presente.
Tutti vestiamo un’armatura di cinismo e indifferenza per sopravvivere in un mondo che ci vuole così, ma forse io sono troppo giovane e folle per fare finta di crederci.
Insomma, Orwell lo scrisse nero su bianco in “1984”, una delle sue più celebri opere: “«Winston, come fa un uomo a esercitare il potere su un altro uomo?» Winston rifletté. «Facendolo soffrire» rispose”.
Dunque, per soffrire, soffriamo, perciò speranza non ne abbiamo e quindi ne abbiamo: direi che disponiamo di tutto il necessario per dire che la vita si vive, la morte si muore e quel che sta in mezzo, con buona probabilità, si muove.
Giselle Passannante Grimaldi 5ª A Liceo scientifico