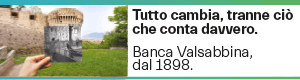La Russia di Putin e il recupero della simbologia sovietica
Sul finire del 2022 sono ricorsi il centesimo anniversario della creazione dell’Unione Sovietica (30 dicembre 1922) e il trentunesimo anniversario dell'accordo di Belaveza (8 dicembre 1991) che ne sancì lo scioglimento come soggetto di diritto internazionale e come unità politica.
Oggi proprio da quella Bielorussia dove si celebrò l’epilogo dell’URSS sembrano soffiare ulteriori venti di guerra che potrebbero portare a un pieno coinvolgimento militare nel conflitto russo-ucraino della nazione guidata dal discusso presidente filorusso Alexander Lukashenko e rilanciare le mire espansionistiche russe.
Si è molto discusso sulla portata di dell’accordo di Belaveza e sui rapporti tra l’era sovietica e quella post-sovietica.
Per molto tempo, almeno fino alla conclusione della presidenza di Boris Eltsin (dimessosi nel dicembre del 1999), le ricostruzioni avallavano soprattutto la tesi di una discontinuità tra il periodo sovietico e quella della Russia odierna che, tra tante contraddizioni, nel corso degli anni Novanta si era aperta a un’economia di mercato (seppure di tipo oligopolistico) e sembrava (seppure con molti limiti) aver avviato il passaggio a un sistema almeno formalmente democratico.
Tuttavia, una serie di errori negli anni della transizione, la svolta politico-culturale impressa alla Russia da Putin nel corso dei suoi quattro mandati presidenziali (2000-2004, 2004-2008, 2012-2018 e 2018-in corso) e dei due da primo ministro (1999-2000 e 2008-2012), e la partecipazione diretta della Federazione Russa ad alcuni conflitti in alcune delle ex repubbliche sovietiche come le guerre in Cecenia (1994-1996 e 1999-2009), Abcazia (1992-1993), Ossezia del sud (1991-1992 e 2008), Transnistria (1991-1992), Crimea (2014) fino agli avvenimenti più recenti sul fronte russo-ucraino, suggeriscono di rileggere in parte i significati dell’accordo stipulato nel 1991 in terra bielorussa.
Alcuni studiosi, come lo scrittore russo in esilio, Sergej Lebedev, senza mezzi termini, ritengono che l’URSS è sicuramente caduta sul piano del diritto e come entità politica ma non lo è davvero su quello delle pratiche politiche e delle pesanti eredità che ancora oggi condizionano la società russa e i paesi dell’ex blocco sovietico.
Nel recente testo “Nostalgia e autoritarismo: l’eredità tossica dell’Unione Sovietica”, egli sostiene che un rilevante aspetto sul quale l’accordo di Belaveza non avrebbe avuto ricadute reali è il potere di controllo posseduto dall’appartato per la sicurezza interna (ieri Kgb, oggi Fsb) e il persistente peso delle strutture militari delle sempre imponenti forze armate.
Negli anni recenti, complice l’irrigidimento autocratico e l’esigenza di creare consenso interno per le politiche espansioniste come l’”operazione militare speciale”, si sarebbe poi alimentata una rinascita di alcuni simboli dell’Unione Sovietica (depurati dalla connotazione comunista), funzionali al consolidamento delle strutture di potere esistenti.
Altri simboli ed eventi del passato sovietico, poco utili alle esigenze comunicative odierne, sarebbero invece stati rimossi.
Come tutti i regimi totalitari, anche l’Unione Sovietica è stata una grande produttrice di simboli volti a esaltare all’interno e all’esterno la superiorità del proprio regime.
Su tutti viene oggi riscoperta la celebrazione della “grande guerra patriottica” che impegnò l’Armata Rossa e il popolo russo contro il nazi-fascismo tra il 1941-1945, conseguendo una vittoria storica, con un sacrificio enorme in termini di distruzioni subite e di vite umane perse.
Si tratta di un evento che oggi è riscoperto per cercare di conferire legittimità a una politica aggressiva e dispendiosa che viene spesso presentata dal Cremlino come una necessaria attività di autodifesa.
La tesi sostenuta da Lebedev e da altri osservatori sulla sostanziale continuità tra l’Unione Sovietica e l’attuale fase putiniana, pur presentando alcuni limiti, ha certamente il pregio di rilanciare il dibattito sull’identità della Russia di oggi.
Rispetto all’URSS la Russia presenta un assetto politico ed economico altamente privatizzato ma al suo interno permane del passato sovietico un notevole peso di alcuni apparati ed è rimasto intatto il bisogno di aggrapparsi ad alcuni simboli collettivi come strumenti di autolegittimazione e di creazione del consenso.