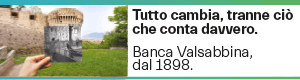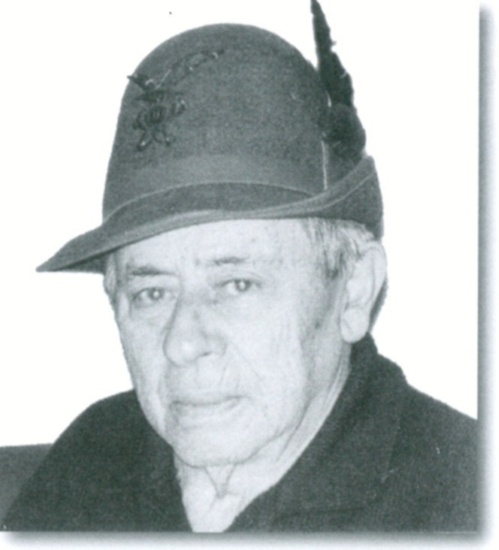C’è chi disse No
Il ricordo di alcuni prigionieri nella Giornata degli Internati Militari nei campi nazisti
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato i militari italiani “che ebbero il coraggio di pronunciare il loro No al nazifascismo, pagando un prezzo personale altissimo e subendo, al termine della guerra, una sorta di oscuramento della loro resistenza, travagliata ed eroica.”
Dopo il fatidico 8 settembre 1943, circa 650 mila militari disarmati vennero posti davanti ad una tragica scelta: continuare a combattere nelle file dell’esercito tedesco o della Repubblica di Salò oppure essere deportati nei campi di concentramento. Ma il 95% disse “No”, e fu impiegato in lavori forzati. I nostri soldati avevano lo status di prigionieri di guerra e, secondo la convenzione di Ginevra, non potevano essere sottoposti a lavoro forzato. Il Governo tedesco invece cambiò la loro denominazione in Internati Militari Italiani (IMI) per sfruttare la manodopera dei prigionieri a costo zero e in condizioni di schiavitù. Nei lager morirono 60 mila internati militari in Germania, uno su dieci: e anche quella fu Resistenza.
Ha scritto Aldo Cazzullo: “La vicenda degli IMI è stata per decenni pressoché dimenticata, per diversi motivi: il desiderio del Paese di voltare pagina e non sentir più parlare della guerra e delle responsabilità del fascismo; la loro resistenza in nome di un re e di una dinastia andati via dall’Italia; la scelta del silenzio da parte degli stessi reduci, delusi dal mancato riconoscimento della propria esperienza come contributo alla Resistenza; il fardello di aver combattuto la guerra voluta dal fascismo e la memoria della rovinosa dissoluzione dell’esercito all’indomani dell’armistizio, in un clima di tutti a casa.”
Questi eroi sono tantissimi, e non posso qui citarli tutti: mi permetto di ricordarne alcuni. Lo scrittore Giovannino Guareschi (l’autore di Peppone e don Camillo), l’attore Gianrico Tedeschi, il tenente degli alpini Giuseppe Lazzati (poi Rettore dell’Università Cattolica di Milano), il papà di Vasco Rossi, Giovanni Carlo, Oreste Del Buono, Mario Rigoni Stern, Tonino Guerra, Luciano Salce, Ferruccio Guccini padre del cantautore Francesco. L’alpino Teresio Olivelli scelse di finire nel campo di concentramento per non abbandonare i compagni di sventura e che morì in un lager nazista per aver cercato di proteggere dalle botte degli aguzzini un prigioniero ucraino.
A Brescia Lino Monchieri: insegnante, direttore didattico, ispettore tecnico superiore del Ministero della pubblica istruzione, autore di testi scolastici, redattore e direttore di riviste presso l’editrice «La Scuola».
A Gavardo Giuseppe Zane, Isidoro Codenotti detto “Doro”, Mario Bertuetti, Vittorio Pontiggia, il marinaio Silvio Venturelli, Alberto Faini (che tutti chiamavano Vittorio), il Generale Giuseppe Giacobinelli, Carlo Zucchetti.
Domenico Buccella fu costretto al lavoro in un’acciaieria presso Hannover. “Mi fecero lavorare con turni di 12 ore al giorno e una fame che non finiva più. Ci davano della brodaglia per colazione, niente a pranzo, a cena una fetta di pane e un po’ di zuppa. Il sabato la razione era doppia, serviva anche per la domenica: la mangiavo subito, altrimenti me l’avrebbero rubata.” In agosto si ammalò e fu trasferito nell’ospedale. “Altro che ospedale. Mi hanno portato a Bergen-Belsen” Era uno dei più terribili campi nazisti, dove denutrizione e malattie causarono la morte di migliaia di persone, tra le quali una ragazza di nome Anna Falk…Ho visto scene terribili. Se ho potuto scamparla è stato per un incredibile colpo di fortuna. Il 26 ottobre mi prendono e con un gruppetto di miei compagni mi rimandano ad Hannover, dove servivano alcuni operai. Non so perché abbiano scelto proprio me. E’ stato un puro caso. So però che grazie al caso io sono ancora vivo. Mi trasferirono ai lavori forzati in un zuccherificio e poi in un salumificio: fu la mia salvezza. Sgobbavo come uno schiavo, ma almeno lì non crepavo di fame. Ho continuato a salare pancette sepolto in una cantina insieme a un prigioniero russo fino al 10 aprile ’45, giorno in cui in città sono entrate le truppe americane”.
A Villanuova s/C l’alpino Nicola Cocca scrisse: “Venti mesi di spostamenti in vari campi di concentramento, dall'Austria alla Polonia, all'Alsazia-Lorena alla Prussia Orientale e come compagna la fame, quella fame brutta che ti fa perdere l'amor proprio, che ti porta alla pazzia, che ti spinge a rischiare la vita perché tanto senti che la tua vita non vale più. Durante un trasferimento passammo vicino a degli alberi di mele, ce ne sono tante appese e tante per terra; do una rapida occhiata, esco dalla fila di corsa e cerco di prenderne quante più ne possono tenere le mie mani. Uno sparo mi gela il sangue: adesso ci siamo tocca a me - penso, mentre alzo le mani in cielo sperando. Mi giro lentamente. Ai piedi giace uno del '13, aveva 3 figli e una moglie, l'ufficiale tedesco che controllava la colonna gli ha sparato a bruciapelo nella schiena, lo ha ucciso per una mela. Al nostro arrivo a Innsbruck c'erano donne e bambini delle scuole ad attenderci e, mentre entravano nel campo recintato, ci sputavano addosso, ci tiravano calci e parole. I trasferimenti avvenivano, se non a piedi, nei carri bestiame, anche in settanta per vagone, chiusi, senz'aria, né cibo, né acqua: un liquido da bere c'era, era la nostra urina…Un giorno mi feci male a una spalla e non ero più in grado di lavorare. Mi trasferirono allora a Buchenwald per essere cremato: non essendo più carne da lavoro non servivo più. Riuscii non so come, a farmela guarire e rientrai al mio lavoro. Una volta mi trovarono due patate nascoste: per punizione mi fecero girare intorno al campo, a corse, completamento nudo. E c'era la neve.
Il freddo va affrontato con quei pochi cenci che avevo addosso. Portavo in pieno inverno degli zoccoli olandesi in legno. Un mattino mi sveglio e intorno a me sono quasi tutti morti. Prendo degli scarponi a uno che sembra avere la mia misura: a te non servono più, mi dico… La vita mi ha insegnato a non serbare rancore. Bisogna perdonare, ma non dimenticare. Nel Lager pregavo la Madonna della Neve di poter rivedere i miei cari: liberato dagli americani, quando sono tornato a casa alla fine del'45 pesavo 42 chili. L’anno dopo ero già al Cotonificio.”
Aldo Arrighi e Marco Flocchini furono invece trasferiti in prigionia negli USA.
A Salò ricordo il Tenente Medico Giorgio Pirlo, mio zio Fausto Comini, mio papà Luigi e il suo compagno di prigionia Merigo da Puegnago.
Mio papà sarebbe destinato a lavorare in miniera in un campo di lavoro in Polonia, ma fortunatamente grazie alla conoscenza della lingua tedesca acquisita alla Giovane Salò gli viene conferito il ruolo di interprete tra i prigionieri ed i soldati tedeschi. Poi si fece spedire un vocabolario tedesco-italiano da casa. I libri a volte salvano la vita.
Raccontava di aver visto un prigioniero italiano ucciso da una raffica di mitra per aver allungato la mano per raccogliere una patata, fuori dal reticolato.
E quando sono arrivati i russi ed hanno liberato il campo, mio papà è stato fermato da un ragazzo russo ubriaco e con il mitra in mano. Teneva una sveglia al collo, stava per sparargli ma per fortuna è arrivato un altro russo che ha dato due ceffoni al ragazzo e mio papà si è salvato. Si è fatto tutta la strada dalla Polonia all’Italia a piedi, attraverso un viaggio avventuroso e pieno di insidie, passando per l’Austria. Un giorno vide fuori da una canonica austriaca un bel paio di scarpe e le ha prese (qualcuno dice sorridendo che lì sono iniziate le Calzature Comini). Ma erano passati molti giorni, e non era ancora arrivato a casa.
Mia mamma aveva sentito che molti prigionieri si trovavano a Linz, e avrebbe voluto andargli incontro. Tutti i santi giorni la nonna Francesca lo aspettava alla fermata del tram. Un po’ alla volta tutti tornavano, ma mio papà non era ancora arrivato a casa. E mia nonna e mia mamma aspettavano sempre, e nessuno aveva il coraggio di dir loro niente. Perché tanti non erano più tornati, perché la guerra è una cosa brutta e cattiva. E la guerra ormai era finita, ma mia nonna aspettava sempre alla fermata del tram. Finché un giorno è sceso dal tram uno così magro, ma così magro, ma l’ha riconosciuto subito che era il suo Luigi, e allora mia nonna ha attraversato la Fossa camminando verso casa, e non aveva parole, e il cuore le tremava dall’emozione, e mio papà dietro, e camminavano senza dirsi niente. E ancora adesso che sto scrivendo mi scoppia il cuore e non riesco a immaginare il volo di mia mamma verso il suo Luigi. Era un bel giorno di settembre del ’45.
maestro John
Nelle foto:
- Mio papà Luigi Comini (il secondo da dx) a Salò dopo la Liberazione, mentre parla l’alpino-partigiano Angio Zane
- Domenico Buccella
- Nicola Cocca
- Aldo Arrighi