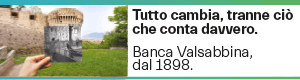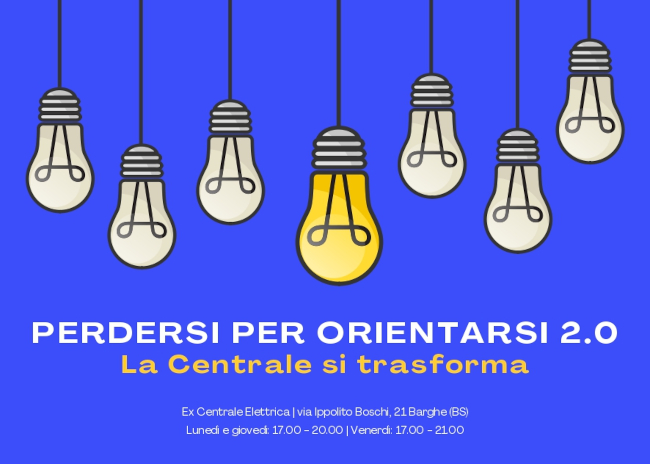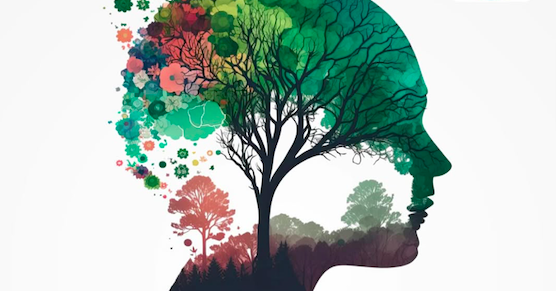Se l'emergenza diventa ordinaria
Le criticità verificatesi negli ultimi giorni, in più parti della provincia di Brescia, a causa dell’improvviso e intenso maltempo, mostrano quanto si sia allentato e quanto sia urgente ricostruire il nostro rapporto col territorio.
Nubifragi, grandinate, cadute di alberi e frane sono eventi che sollevano molti interrogativi sul piano delle cause ma anche su quello delle reazioni, se non altro perché continuiamo a viverli con atteggiamenti di sorpresa, quasi d’incredulità, malgrado il loro drastico incremento negli ultimi anni e nonostante le proiezioni sul prossimo futuro non lascino intravvedere concrete vie d’uscita.
Si fatica a comprendere che siamo, ormai, nell’epoca delle conseguenze e della cronicizzazione delle emergenze ovvero in una fase storica nella quale si toccano con mano le ricadute dell’azione umana sugli ecosistemi.
Raccogliamo così, non solo i frutti invitanti e avveniristici della modernizzazione, dell’urbanizzazione e dello sviluppo tecnologico, ma anche i frutti avvelenati che questi stessi processi storici ci consegnano, in primo luogo in termini di squilibri ecologici.
Il fatto che ogni evento meteorologico intenso, dal troppo caldo al troppo freddo, dalla siccità alle inondazioni, dall’afa alle forti raffiche di vento, porti con sé rischi e pericoli per l’incolumità e per la salute delle persone, sta a significare che siamo già ora nel bel mezzo del mutamento climatico.
Il nostro stupore di fronte a questo cambiamento ci dice che scontiamo ancora un ritardo politico, culturale e gestionale dovuto al minor peso che sulla “bilancia” della risposta territoriale continuiamo ad assegnare agli interventi di pre-emergenza rispetto a quelli di post-emergenza.
Non si tratta certamente di trasferire risorse umane ed economiche dal secondo al primo “piatto”, ma piuttosto di aggiungerne di nuove affinché la bilancia si metta in equilibrio riconoscendo fino in fondo, e a più livelli, il valore strategico che oggi assume la prevenzione.
Fare quindi di più e meglio per prevedere, prevenire e mitigare i rischi e comunicare di più e meglio quello che già si fa in questo campo, in modo da diffondere la consapevolezza del valore di alcune attività e di determinati investimenti di tempo e denaro.
Ad esempio, segnalare con tempestività le prime avvisaglie di uno smottamento, curare la piantumazione ai bordi delle strade, ripulire periodicamente gli scolmatori, sono azioni concrete, forse mediaticamente poco eclatanti, che però si traducono nel salvataggio preventivo di vite umane e nel risparmio di fondi pubblici che sarebbero ben più consistenti se dovessero arginare un’emergenza.
Sul fronte della prevenzione basti pensare a quanto già oggi fa la Protezione Civile della quale spesso si parla solo in occasione della gestione dei momenti caldi di un’emergenza.
Un contributo strategico, quello di questo servizio, che potrebbe addirittura accrescersi se valorizzato nell’ottica di una diretta collaborazione con le comunità e le amministrazioni locali.
Del resto, sono molti i rischi che oggi incombono e che richiedono un attento monitoraggio del territorio finalizzato a evidenziare sia le fragilità note sia i pericoli inattesi o addirittura sottovalutati che vanno però conosciuti e gestiti per tempo.
Più in generale, servirebbe un programma a lungo termine di cura preventiva del territorio che non prescinda dalla ricostruzione di un legame profondo tra comunità locali e ambiente e da un deciso cambio di rotta nelle politiche di pianificazione territoriale che per troppo tempo non si sono interrogate sulle ricadute nel lungo periodo di alcune opzioni.
(tratto dal Giornale di Brescia)