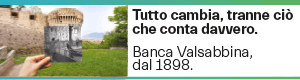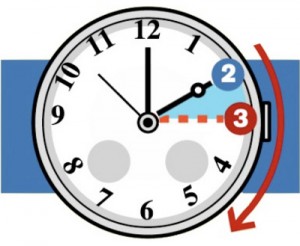L'opera delle Confraternite
Le Confraternite erano costituite da laici appartenenti alla Chiesa che si riunivano per promuovere opere di carità e di pietà, per incrementare il culto e l’educazione religiosa oltre che per contribuire alla realizzazione di specifiche cerimonie liturgiche (processioni, devozione verso i santi, ecc.). Nella loro attività erano previsti interventi a sostegno della parte più povera della comunità e di coloro che erano in situazione di vulnerabilità (orfani, vedove, malati, infermi, anziani, ecc.).
L’appartenenza si traduceva nella partecipazione a momenti di preghiera che venivano condotti all’interno di specifiche chiese, cappelle o piccoli spazi per il culto (oratori). Aspetto importante era il sostegno spirituale e materiale nei momenti della malattia e nell’accompagnamento dei moribondi verso la “buona morte”, mediante la costante preghiera per la loro conversione e in suffragio della loro anima.
I membri di queste aggregazioni sentivano l’esigenza di associarsi e di aiutarsi reciprocamente per affrontare situazioni di necessità non altrimenti gestibili che caratterizzavano la vita di molte persone. Per questo si dotavano di un’attenta organizzazione. Come ebbe a scrivere il sociologo della religione Gabriel Le Bras (1941), ciascuna confraternita “aveva le proprie assemblee, i propri statuti, i propri funzionari, il proprio bilancio, una struttura, insomma, che evocava, ad un tempo, i gruppi religiosi, le corporazioni professionali e il modello di tutti i governi, la città. In verità, il suo tratto distintivo e dominante era d’essere una fratellanza, una fratellanza soprannaturale e non, come le altre, artificiale, perché tutti i suoi membri erano uniti nel Cristo e dal Cristo: la dottrina del Corpo mistico esprime quest’unità profonda”.
Le Confraternite, esistenti fin dai primi secoli dell’era cristiana, conobbero una notevole diffusione nel basso medioevo e nel periodo della Controriforma, tanto da essere presenti sia nelle grandi città, sia nei piccoli centri di provincia. La loro costituzione richiedeva (e richiede) di essere riconosciuta e approvata dall’autorità ecclesiale e sottoposta a una specifica disciplina del diritto canonico.
Durante il periodo napoleonico (1796-1814) furono soppresse, con poche eccezioni come, ad esempio, per le Confraternite del Santissimo Sacramento collegate alla festa del Corpus Domini e al culto pubblico dell’eucaristia fuori dalla Messa. Tra Ottocento e Novecento vi fu una ripresa delle attività delle Confraternite (spesso collegate alla pietà popolare) anche se non raggiunsero i livelli di diffusione e di adesione del periodo pre-napoleonico.
A Brescia le Confraternite più note, e ancora esistenti, sono quelle dei Santi Faustino e Giovita, dell'Immacolata adoratrice del SS. Sacramento e di Santa Maria delle Consolazioni.
Questi sodalizi hanno rappresentato forme embrionali dell’odierno associazionismo laicale ma anche organizzazioni anticipatrici delle moderne società di mutuo soccorso. Un segno visibile della loro importanza è dato dal lascito artistico. Le Confraternite contribuirono alla costruzione di edifici di culto, commissionando la realizzazione di decorazioni, sculture, dipinti molto spesso incentrati sul tema della passione e morte di Cristo che ancora oggi si possono ammirare anche in molte chiese della Valle Sabbia.
in foto:
. S. Rocco portato in processione dalla Confraternita del SS. Sacramento,Polpenazze primi anni '50
. “Deposizione dalla Croce” (1580), dipinto conservato nella Chiesa dell'Ascensione di Volciano presso l’Altare dell’antica Confraternita del Santissimo Sacramento