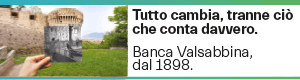Dove sono trasparenza e volontà politica?
Come sempre ben informato su ciò che ruota attorno al lago valsabbino, e un po' anche del suo Trentino, l'ex consigliere regionale Alex Marini propone nel suo blog una sua disamina sulle inefficienze manifestate dalla pubblica amministrazione in merito alle questioni ambientali. Pubblichiamo volentieri
Lago d’Idro: mancanza di studi ecosistemici e trasparenza sotto il livello di guardia
Le nuove opere di regolazione del Lago d’Idro hanno portato alla luce diverse criticità riguardanti la gestione del procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e la scarsa trasparenza delle amministrazioni coinvolte.
Come evidenziato nell’analisi precedente, la proroga della VIA è stata concessa senza un adeguato coinvolgimento degli enti locali e senza garantire una reale partecipazione pubblica. Questo approccio ha non solo sollevato dubbi sulla legittimità del procedimento, ma anche trascurato la necessità di approfondire gli impatti ambientali di un progetto che interessa un ecosistema complesso e fragile.
Per colmare questa lacuna informativa, siamo ricorsi al Difensore Civico, riuscendo a ottenere le relazioni del Museo Civico di Rovereto e del Museo delle Scienze di Trento (MUSE), dopo che il Servizio aree naturali della Provincia di Trento aveva opposto un silenzio alle nostre richieste di accesso agli atti.
Lo scopo della richiesta era comprendere se gli studi commissionati avessero fornito elementi utili per valutare le conseguenze delle variazioni del livello del lago, con particolare attenzione al biotopo di Baitoni. Tuttavia, da una prima analisi delle relazioni, l’approccio adottato dai soggetti incaricati risulta inadeguato rispetto alla complessità degli impatti ecologici che queste opere potrebbero comportare.
In questo post analizziamo le principali lacune di questi studi e riflettiamo sulle implicazioni di una gestione poco trasparente e priva di una visione sistemica nella tutela del patrimonio naturale rappresentato dal Lago d’Idro.
I rapporti dei musei trentini sui monitoraggi
Le relazioni sono state sottoposte a un esperto del settore, che ha evidenziato alcune criticità che proviamo a riassumere nella speranza di poter ottenere ulteriori riscontri analitici:
1. La relazione intermedia della Fondazione Museo Civico di Rovereto (ottobre 2023): il lavoro è puntuale e preciso, con dati rigorosi, ma manca completamente di una discussione o di analisi approfondite. In sostanza, è un esercizio di catalogazione e censimento delle specie vegetali presenti, senza offrire interpretazioni utili alla comprensione delle dinamiche ecologiche.
2. La sintesi delle attività di monitoraggio 2023-24 svolte dal MUSE per AIPO (ottobre 2024): questo lavoro è più articolato, toccando diverse matrici biologiche animali e includendo spunti interessanti sullo stress provocato dalle variazioni del livello del lago. Tuttavia, pur sottolineando gli effetti negativi dell’abbassamento delle acque, non fornisce stime concrete sull’impatto sulla biodiversità.
Manca un approccio sistemico e funzionale, con l’uso di indicatori ecologici o indici statistici per valutare le relazioni tra i comparti dell’ecosistema, l’efficienza dei trasferimenti di energia e materia e i servizi ecosistemici. Anche questo lavoro riflette un’impostazione prevalentemente museale, concentrata sulla catalogazione piuttosto che sull’analisi ecosistemica.
In sintesi, si tratta di studi specialistici di buon livello nel campo naturalistico, ma non sufficienti a comprendere la complessità ecologica del biotopo lacustre.
Sono più vicini a censimenti che a una reale indagine sulle funzioni, relazioni e interazioni tra gli elementi dell’ecosistema.
Le criticità: assenza di trasparenza e di volontà politica
Questa vicenda mette in evidenza due criticità principali.
1. La mancanza di trasparenza: l’atteggiamento di chiusura delle pubbliche amministrazioni sulla gestione delle informazioni ambientali è sconcertante.
L’accesso e la pubblicazione di questi dati dovrebbero essere agevolati e tempestivi, non costringere i cittadini a ricorrere a vie legali per ottenerli.
2. L’assenza di volontà politica: sembra evidente che non vi sia un interesse concreto a condurre studi approfonditi sulla complessità dell’ecosistema del lago confermando l’atteggiamento di chiusura già manifestato in passato.
Gli studi disponibili si limitano al minimo indispensabile, senza creare opportunità di condivisione dei dati, di verifiche peer review per migliorarne la qualità e di integrazione in una logica di studio dei servizi ecosistemici.
Un elemento ancora più grave è rappresentato dai tempi degli studi commissionati.
Lo studio del MUSE, iniziato nella primavera del 2023 e terminato nell’ottobre del 2024, è stato completato ben oltre la conclusione dell’iter che ha autorizzato la seconda proroga del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per le nuove opere di regolazione del lago d’Idro.
Analogamente, lo studio del Museo Civico di Rovereto, concluso nell’ottobre del 2023, non può aver fornito dati utili alla valutazione di incidenza prodotta durante la procedura di proroga della VIA.
Nonostante queste evidenze, la VIA è stata approvata senza alcun intoppo, con il silenzio delle pubbliche amministrazioni coinvolte.
La mancanza di volontà di tutelare l’ambiente naturale
In considerazione delle evidenze raccolte, appare sempre più chiaro che la politica ha preferito “tirare i remi in barca,” favorendo un progetto che sembra orientato più alla speculazione economica che alla sicurezza idrogeologica e alla tutela ambientale.
La mancanza di trasparenza, il ritardo negli studi e l’assenza di un approccio sistemico nell’analisi degli impatti ecologici non sono semplici segnali di inefficienza amministrativa: rappresentano scelte precise che minano la credibilità delle istituzioni e il diritto dei cittadini a un ambiente sano e protetto.
Questi non sono più sospetti, ma fatti concreti che si rendono ogni giorno più evidenti e preoccupanti. È indispensabile un cambio di rotta che metta al centro l’interesse collettivo, la protezione degli ecosistemi e la trasparenza nei processi decisionali.
Diversamente, il lago d’Idro rischia di diventare un emblema dell’inerzia politica e dell’incapacità di tutelare un patrimonio naturale unico.