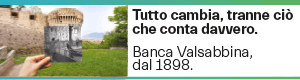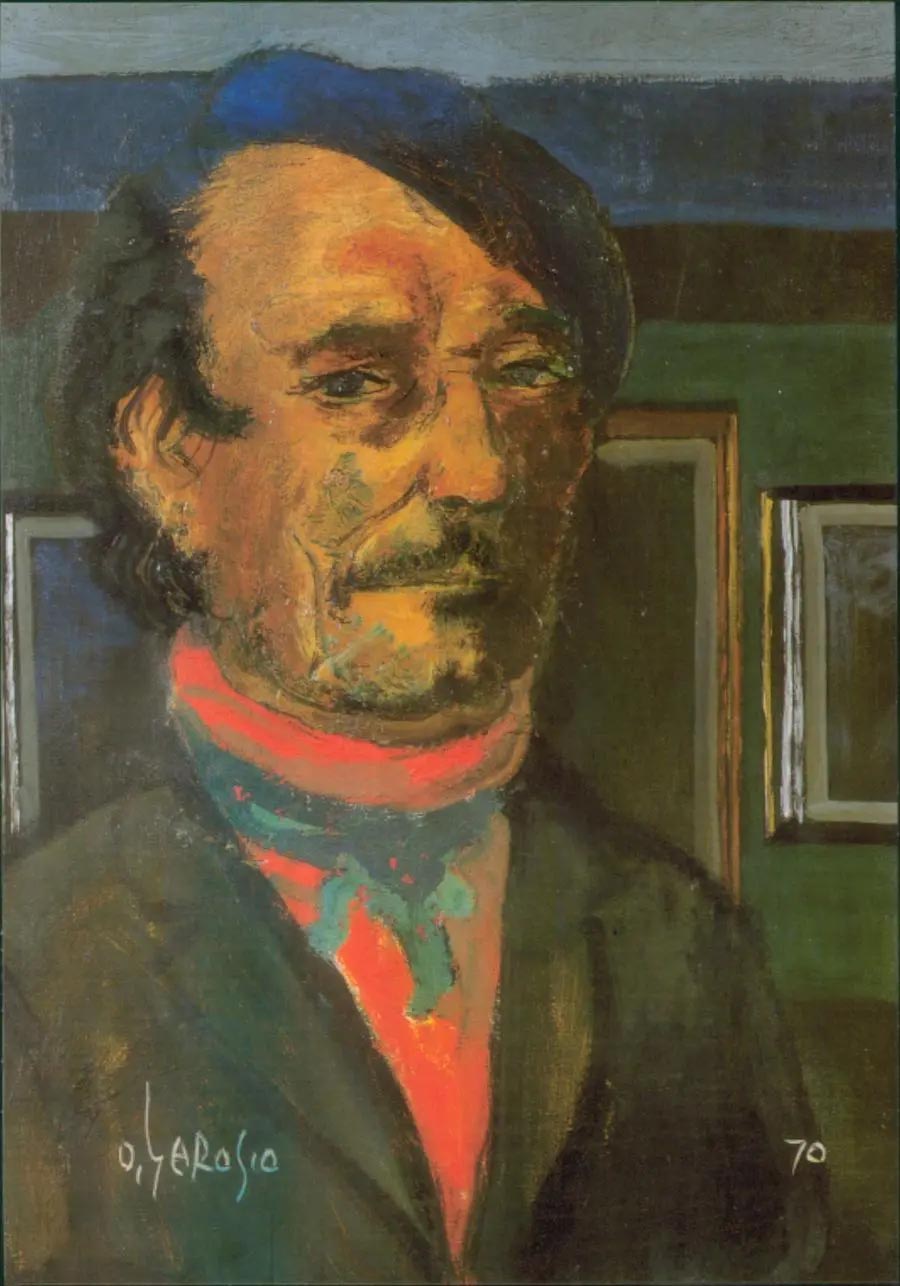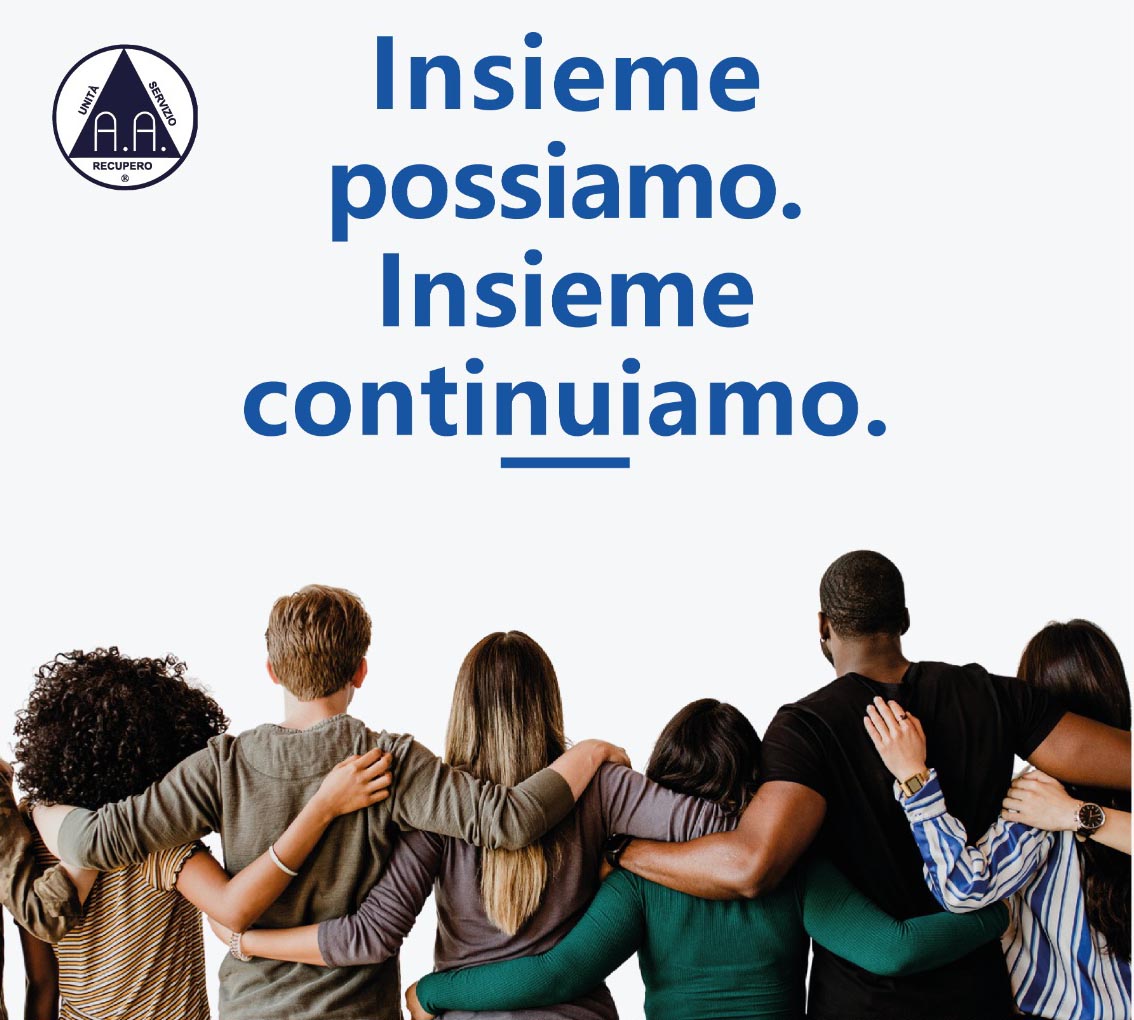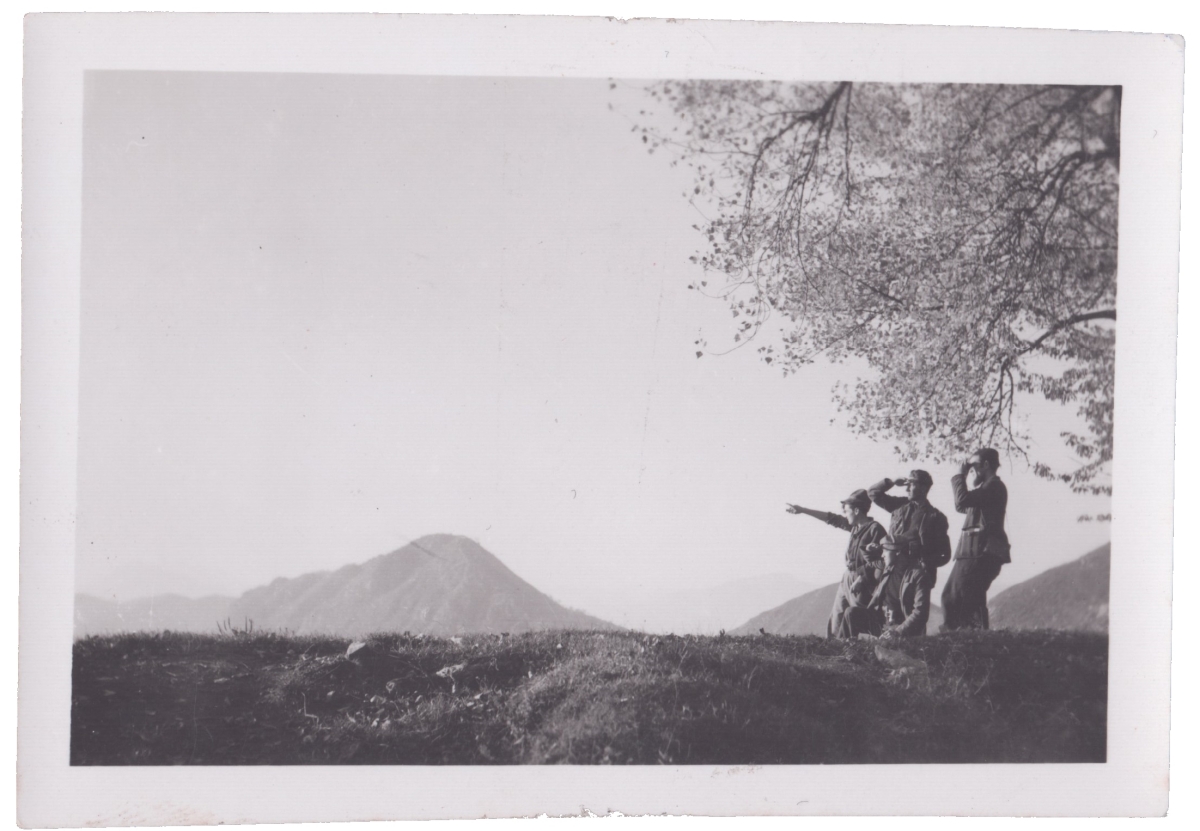Anche ai filosofi “girano...”
Questa filosoficheria è dedicata a chi si illude che la filosofia consista nell’assolvere i propri doveri burocratici quotidiani
Nella storia del pensiero sociologico, il grande Max Weber teorizzò che una società burocratizzata sarebbe stata la più legale e razionale possibile.
Secondo lui, la burocrazia rappresentava il trionfo dell’intelligenza amministrativa sulla confusione delle passioni umane: niente più monarchi dotati di carisma, né santi ispirati alle tradizioni, ma moduli compilati in triplice copia e timbri ben allineati.
E così, secondo Weber, nel fascino discreto del protocollo la modernità avrebbe trovato il suo equilibrio nell’esercizio del potere.
Ora, non è certo, ma viene il sospetto che molti di coloro che oggi frequentano il mondo della scuola si sentano eredi spirituali di questa visione weberiana. Altrimenti come spiegare la proliferazione delle carte da firmare, delle circolari da leggere, dei registri da aggiornare?
“L’importante è che le carte siano a posto”, si sente ripetere come un mantra. E allora, perché non proporre anche un nuovo proverbio popolare: “Una scartoffia al giorno toglie i dissidi di torno”?
Ma – chiediamoci seriamente – che cosa si nasconde dietro queste prassi che quotidianamente sottraggono tempo e neuroni agli insegnanti? Certamente non l’entusiasmo, e nemmeno, sia detto senza offesa, un eccesso di senso del dovere.
In fondo, il dovere del docente non consiste nel redigere relazioni programmatiche, ma nell'incarnare a lezione ciò che l’articolo 33 della Costituzione scolpisce con poetica chiarezza: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.
Dove sta, dunque, l’inghippo?
Semplice: la burocrazia scolastica, più che razionale, è paranoica. Non mira alla giustizia o all’efficienza, ma alla prevenzione dei guai. Non è perizia gestionale, come dovrebbe essere; è autotutela preventiva da polemiche possibili.
Un esempio concreto? L’assegnazione dei compiti.
L’insegnante non li assegna per sadismo – di solito – ma per favorire l’apprendimento. Tuttavia, oggi, la domanda chiave non è più: “I compiti sono coerenti con la lezione?” bensì “Sono stati caricati sul registro elettronico?”.
Perché, si sa, ciò che non è scritto sul registro semplicemente non esiste. “Esse est quod scriptum est!”.
Il vecchio diario scolastico è ormai in pensione, con tanto di TFR e nostalgia per chi è più sviluppato in età. Si badi bene: poco importa se l’annotazione sul registro è sbagliata o inventata: l’importante è che sia lì, nera su bianco, a proteggere l’insegnante da genitori zelanti o dirigenti avvezzi alla caccia ai colpevoli.
Ebbene, chi ama la conoscenza — o almeno ci prova — di fronte a tutto questo non può che sentir “girare” qualcosa. Forse non proprio le ghiandole surrenali, l’intestino o altre parti basse del corpo, ma di sicuro una parte profonda dell’anima.
E chi trova questa metafora viscerale poco elegante, ricordi che nella cultura ebraica il pensiero autentico risiede proprio lì, nelle interiora: dove nascono le emozioni e dove si deposita il potenziale concime dei fiori.
Scherzi a parte, perché la burocrazia irrita tanto chi crede ancora nel valore educativo del sapere?
Per due motivi. Primo: perché si insinua ovunque, colonizzando ogni spazio di libertà e creatività, come un’edera amministrativa.
Sul tema della diffusione capillare del potere, Foucault ha scritto pagine immortali in “Sorvegliare e punire”, testo che, a buon diritto, dovrebbe essere adottato come manuale base nei corsi di aggiornamento per docenti.
Il secondo motivo è più sottile, ma non meno velenoso: la burocrazia crea consenso non attraverso il dialogo, ma attraverso l’obbedienza supposta.
Non c’è bisogno di discutere su cosa sia giusto o educativo: basta rispettare le norme stabilite su regolamenti approvati senza conoscerli.
Così, il comportamento “corretto” diventa quello che non fa alzare sopracciglia, anche se, al contempo, non fa alzare neppure la moralità delle azioni.
A questo proposito, lo psicologo Lawrence Kohlberg ricordava che accettare ciecamente le regole per timore della punizione è tipico di una moralità adolescenziale. Non esattamente il modello di riferimento per un adulto libero e pensante, tantomeno per un insegnante.
Il pieno sviluppo morale, spiegava, si manifesta quando si agisce secondo principi di giustizia universale, non per timore della violazione di una norma, ma per fedeltà alla propria coscienza che riflette intorno al bene e al male.
Ecco, quindi, il punto focale: la razionalità burocratica, per quanto espressione di efficacia amministrativa, pecca di saggezza etica. La storia lo ha mostrato tragicamente con il caso Eichmann, il funzionario nazista che, con zelo amministrativo, organizzò le tratte ferroviarie verso i campi di sterminio di tutt’Europa perché considerava suo obbligo eseguire gli ordini.
La sua difesa in tribunale? Appunto: era stato solo un bravo soldato ubbidiente. Aveva compilato per bene le sue scartoffie. Non credo Weber avrebbe approvato questa legale condotta connessa alla logica burocratica.
Di sicuro, Hannah Arendt si è indignata fino al midollo verso Eichmann e ci ha regalato il suo libro “La banalità del male”, altro capolavoro da leggere nella vita.
Meno male che a lei “è girato” qualcosa dentro mentre guardava il processo ad Eichmann trasmesso in mondovisione.
Meno male che a chi filosofa “girano...” alle volte. Perché, se il pensiero non si origina da ciò che fa letteralmente “girare le balle”, finisce per addormentarsi mentre pone firme ben scritte su protocolli formalmente corretti.
Filosoficheria di Pseudosofos